Tik Tok, il social dell’azienda di Pechino ByteDance cresce in tutto il mondo e invoca «diversità e inclusione». Ma esporta gli standard lavorativi dell’high tech cinese: turni “996” e paghe magre
«Puntare al massimo» e «crescere insieme» sono alcune delle espressioni che compongono un breve elenco del cosiddetto “modello ByteDance”, il codice di condotta aziendale della casa madre del social media Douyin e della sua versione internazionale TikTok. La scorsa settimana il Ceo Liang Rubo, che qualche mese fa si è sostituito al fondatore Zhang Yiming, ha comunicato ai dipendenti di aver aggiornato il codice, nell’ottica di mostrare la via idonea alla dirigenza e agli oltre 160 mila lavoratori: l’espressione «diversità e inclusione», ad esempio, è salita al secondo posto, indice della volontà di «costruire un team diversificato» che abbracci la globalizzazione.
CON UN FATTURATO che nel 2021 ha raggiunto i 58 miliardi di dollari, ByteDance sta puntando ad ampliare l’organico di TikTok, le cui entrate nel 2021 hanno superato i 4 miliardi di dollari. Si prevede che la piattaforma possa toccare i 12 miliardi entro la fine di quest’anno, una cifra enorme, ha riportato Bloomberg, che «la renderebbe più grande di Twitter e Snap (dell’app Snapchat) messe insieme». Lo scorso anno le ha anche riservato il record di app più scaricata al mondo, superando il miliardo di utenti attivi al mese.
Nel 2020, malgrado gli screzi con l’amministrazione Trump, la società aveva annunciato l’intenzione di inserire entro tre anni 10 mila persone nell’organico dei suoi uffici negli Stati Uniti – che ammontava allora a 1500 dipendenti. Quelli negli uffici europei, invece, sono passati da 208 nel 2019 a 1294 l’anno successivo. Team sempre più corposi per sostenere gli intenti di diversificazione di contenuti. I profitti della piattaforma, ad oggi, non dipendono solo dalla pubblicità, ma provengono anche dalla distribuzione musicale e di videogame.
LA SOCIETÀ sta puntando, inoltre, sull’e-commerce, in particolare sul sistema di vendite in livestreaming che ha registrato enorme successo nella Repubblica popolare cinese, supportato da una struttura logistica avanzata e a solide piattaforme di pagamento online come WeChat Pay e Alipay. Douyin lo ha già sperimentato nel 2019, con risultati, neanche a dirlo, più che ottimi. Ma la sua diffusione a livello internazionale sta riscontrando non pochi ostacoli. A giugno il Financial Times si è fatto veicolo di varie lamentele di dipendenti e collaboratori del servizio “TikTok shop”, lanciato nel Regno unito lo scorso anno come primo esperimento fuori dal continente asiatico.
Qualche influencer avrebbe deciso di abbandonare la piattaforma dopo che gli introiti sono stati intaccati dai consistenti tagli al compenso base – a cui si aggiungono le commissioni sulle vendite. I vestiti e le borse disponibili per la vendita in live sono stati tacciati di essere “fast fashion” della peggior specie, di scarsa qualità e, in alcuni casi, contraffatti – malgrado la piattaforma abbia dichiarato di avere linee guida rigorose a riguardo. L’orario di lavoro non sembra sia stato ridimensionato e consiste ancora in due sessioni di livestreaming a settimana per una durata che va dalle due alle sei ore a sessione. Sul quotidiano britannico un dipendente ha accusato ByteDance di aver mostrato «arroganza» per aver esportato un modello di business senza «localizzare l’esperienza».
IL PROCESSO di internazionalizzazione in cui la società sta investendo genera anche tutta una serie di riflessioni sui cambi di prospettiva. Sulla difficoltà, ad esempio, di subire gli «standard culturali e linguistici» che in genere la Silicon Valley impone ad altre regioni del mondo: i dipendenti statunitensi ed europei hanno dovuto rinunciare al cosiddetto «HQ privilege», come lo ha definito la ex project manager di TikTok Usa Melody Chu, che alla sua esperienza di un anno e mezzo nella società ha dedicato un racconto a tre puntate, pubblicato sulla piattaforma di contenuti Medium.
A LEGGERE le sue considerazioni sembra di trovarsi davanti a una combinazione tra un reality survivor e un viaggio spirituale. Ben conscia dei rischi – tra cui una cultura del lavoro famosa per abbracciare il 996, l’orario tipico degli ambienti dell’high tech cinese che prevede un turno dalle nove di mattina alle nove di sera per sei giorni alla settimana – Chu ha comunque deciso di accettare il lavoro viste «le opportunità di carriera e l’apprendimento interculturale».
Le difficoltà maggiori, assieme alle forti barriere linguistiche, derivano dalla necessità di una comunicazione costante con il gruppo amministrativo e decisionale, con base a Pechino e in misura minore a Singapore. Ciò obbliga i dipendenti statunitensi a collegarsi in call di lavoro di domenica sera tardi, quando in Cina sono le prime luci dell’alba di lunedì. «Avevo superato da mesi il mio burnout point», ammette l’autrice, che segue poi a elencare gli insegnamenti che ha ricavato dalla esperienza, tra cui quello di aver dimostrato a sé stessa di essere «resiliente» – sì, usa proprio questa parola.
MA TESTIMONIANZE di questo genere – che sembrano costituire un filone giornalistico a parte atto a svelare i succosi retroscena del successo di TikTok – portano alla luce anche i fattori che ne hanno determinato la crescita da record. Vista la lontananza geografica e la cosiddetta strategia di “closed loop”, che ottimizza il controllo centralizzato e limita la condivisione di dati con parti terze, non è raro che i gruppi lavorino involontariamente su funzionalità identiche. Ma la società ne risente solo marginalmente e punta invece a coltivare una continua competizione tra i team, nell’ottica di assicurarsi un flusso ininterrotto di progetti.
A TikTok sembra che le idee prendano formano in un tempo molto più breve che nelle tradizionali società della Silicon Valley, gli obiettivi di crescita sono maggiori e le scadenze sono più brevi. E la ricerca di talenti è più facile: se manca una certa figura negli Stati uniti, si pesca dall’enorme bacino di neolaureati in Cina, che secondo le stime quest’anno supereranno per la prima volta i 10 milioni.
Di Vittoria Mazzieri
[Pubblicato su il manifesto]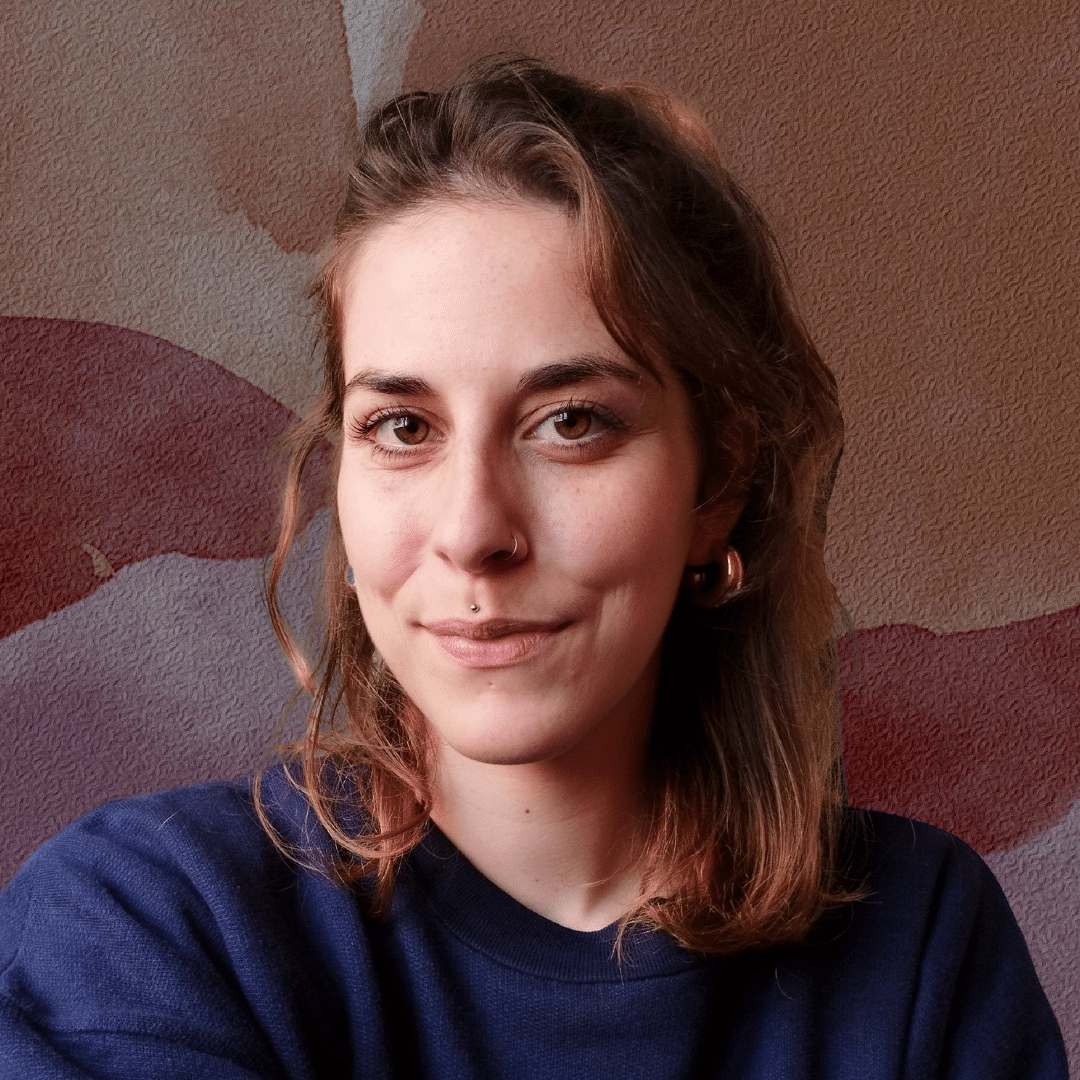
Marchigiana, si è laureata con lode a “l’Orientale” di Napoli con una tesi di storia contemporanea sul caso Jasic. Ha collaborato con Il Manifesto, Valigia Blu e altre testate occupandosi di gig economy, mobilitazione dal basso e attivismo politico. Per China Files cura la rubrica “Gig-ology”, che racconta della precarizzazione del lavoro nel contesto asiatico.

