Film come Burning, Parasite, Oldboy e Pietà hanno in comune diversi elementi: una commistione unica di generi e tecniche di narrazione e la volontà di raccontare storture e ansia del presente
Crisi nera e record al botteghino. Il successo del cinema sudcoreano getta le basi, ironia della sorte, nel periodo più buio dell’economia nazionale. La crisi finanziaria asiatica del 1997 spazza via i decenni di rapido sviluppo che dagli anni Sessanta annoverano la Corea del Sud tra le “tigri asiatiche” a fianco di Singapore, Taiwan e Hong Kong. Ciò che resta è il fallimento di molte chaebol, i grandi conglomerati industriali a conduzione familiare, e la crescita del tasso di disoccupazione che in un anno passa dal 2,5% al 7,6%.
Con un’economia in bancarotta, Seoul è costretta a chiedere al Fondo monetario internazionale 58,5 miliardi di dollari, erogati a condizione che si metta in atto un programma di riforme obbligatorio. È proprio nel periodo di lenta ripresa economica che l’industria del cinema cresce considerevolmente. Nel 1999 conquista il record storico con una quota di mercato del 39,4% (in aumento del 15% rispetto all’anno precedente), che nel 2003 raggiunge il 53,5%.
Come scrive Li Jinying (Brown University) in “Clowns, Crimes, and Capital: Popular Crime-Comedies in Post-Crisis Korea”, il trionfo del cinema coreano “è stato parte di uno sforzo decennale che ha coinvolto il sostegno governativo, la ristrutturazione industriale, l’influenza aziendale e l’esuberanza culturale”. Un ruolo essenziale in questo processo va riconosciuto all’afflusso finanziario da parte dei grandi conglomerati e dei venture capitalist, che malgrado le critiche sul loro ruolo nel settore, permettono di sistematizzare il mercato.
Di fatto, è il cinema a trainare la “Hallyu”, neologismo di incerta provenienza che celebra la Corea come una nuova figura di spicco della cultura pop in Asia, e poi nel mondo. Film, musica pop, moda, makeup e cibo delineano “una nuova fase di sviluppo economico che enfatizza il ruolo della proprietà intellettuale e della creatività nel processo di produzione”, come spiega John Walsh in un contributo per il testo multidisciplinare “The Korean Wave: Korean Popular Culture in Global Context”.
L’onda lunga del cinema porta con sé un sapiente uso di generi e sensibilità diverse e, soprattutto, la necessità di raccontare i drammi di un’intera nazione: l’occupazione giapponese, la guerra civile, il colpo di stato militare degli anni Sessanta, l’avvento della democrazia, la crisi finanziaria. Tappe di una memoria collettiva che vengono riproposte lungo una linea temporale, ma a ritroso, in Peppermint Candy del 1999 (titolo coreano: Pakha Satang). Diretto da uno dei protagonisti della “Hallyu”, Lee Chang-dong, il film inizia dalla fine della vita del tormentato Yong-ho, per poi condurre lo spettatore indietro nel tempo.
Le voci che popolano l’industria di quei primi anni appartengono alla cosiddetta “generazione 386”, nata negli anni Sessanta in pieno colpo di stato militare e poi protagonista del movimento democratico degli anni Ottanta. Uomini e donne provano a dare forma alla frustrazione accumulata negli anni dell’oppressione autoritaria, che li ha obbligati ai margini della vita sociale, alla stregua di osservatori passivi nell’ombra. Nel suo Oldboy (2003), secondo capitolo della “trilogia della vendetta”, Park Chan-wook la narra attraverso la storia tormentata di Oh Dae-su, costretto senza spiegazioni o avvertimenti a vivere per 15 anni rinchiuso in una camera d’hotel.
Storie di fallimenti, povertà e tormenti esistenziali contraddistinguono produzioni indipendenti e successi al botteghino, blockbuster e b-movie. Che i film servono per dare voce alle proprie ansie lo ammette anche Bong Joon-ho, regista acclamato per il premio Oscar Parasite. Il suo The Host (Gwoemul, in coreano), monster-movie che si fonde con la commedia e con la tragedia, è stato capace di stabilire in patria un nuovo record di incassi con oltre 13 milioni di biglietti venduti. Ed è subito stato interpretato come portatore di quelli che Michael G. Vann su Jacobin descrive come “consapevoli riferimenti ai sentimenti antiamericani”: è un bellicoso scienziato statunitense, di fatto, a ordinare a un suo subalterno sudcoreano di scaricare una quantità tossica di formaldeide nello scarico.
Nello smentire le semplificazioni, il regista ammette di aver preso ispirazione da un caso di cronaca risalente ai Duemila e diffuso dalla stampa nel periodo in cui il film era in progettazione, aggiungendo che “se Hollywood può costantemente rappresentare altre nazioni come cattivi, allora perché gli Stati Uniti non possono diventare oggetto di satira nei film di altre nazioni?”. In sostanza, il film denuncia i danni causati dall’uomo agli habitat naturali e, soprattutto, punta il dito contro i governi pronti a trasformare i cittadini in cavie da laboratorio.
[Un estratto dall’ultimo e-book di China Files Cinema & Asia (per sapere come ottenerlo, clicca qui)]
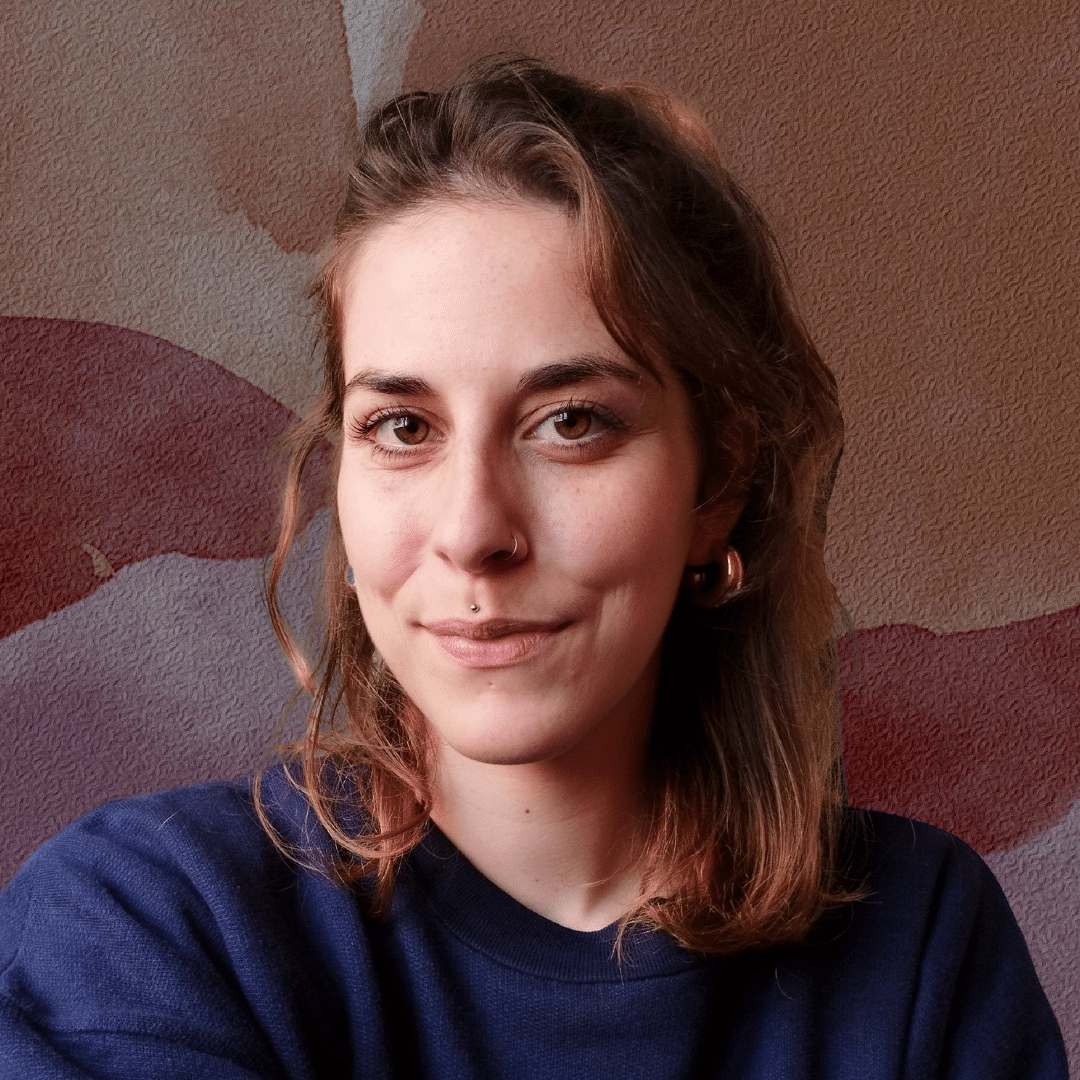
Marchigiana, si è laureata con lode a “l’Orientale” di Napoli con una tesi di storia contemporanea sul caso Jasic. Ha collaborato con Il Manifesto, Valigia Blu e altre testate occupandosi di gig economy, mobilitazione dal basso e attivismo politico. Per China Files cura la rubrica “Gig-ology”, che racconta della precarizzazione del lavoro nel contesto asiatico.


