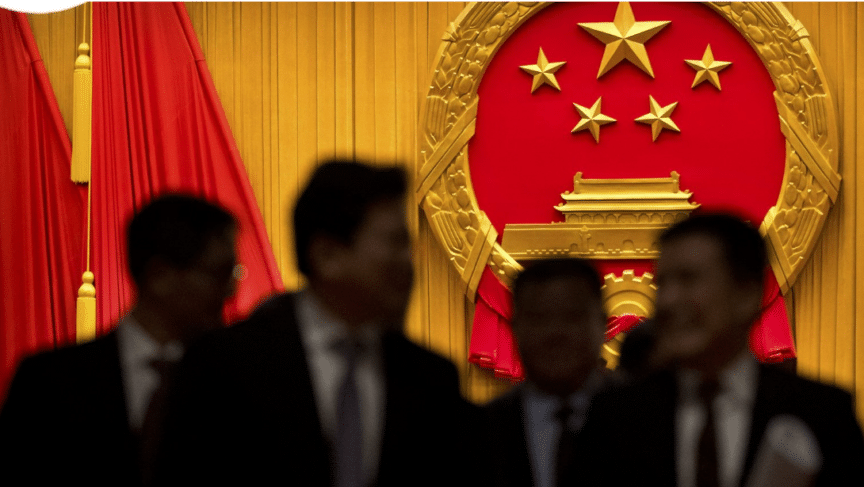“L’avvenire della civiltà dipende dal compito che i cinesi si assumeranno in questo secolo.” La profezia di Benito Mussolini potrebbe avverarsi con cento anni di ritardo. O almeno questo è quello che sembra pensare il gruppo dirigente di Pechino. Dopo tre anni di stallo, dedicati a perseguire la politica “Zero Covid”, la Cina si è riaffacciata al mondo con una grande missione: arrivare non solo a giocare un ruolo internazionale di primo piano, ma anche a scrivere le regole del gioco.
Tutto è cominciato, nel 2022, con la partecipazione di Xi Jinping ai vertici della Shanghai Cooperation Organization (SCO) in Uzbekistan a settembre, e del G20 in Indonesia a novembre. Dopo il prolungato lockdown, il presidente è parso voler riportare la Cina al centro delle dinamiche globali per scongiurare un isolamento “fisico” che dall’inizio della guerra russo-ucraina è diventato anche sempre più un isolamento politico: “l’amicizia senza limiti” – dichiarata a Vladimir Putin nel gennaio 2022 – condannata dalle cancellerie europee, ha fornito agli Stati Uniti un ulteriore espediente per emarginare Pechino, facendo leva sul risentimento condiviso dai “like-minded countries”, i Paesi alleati degli Stati Uniti tra cui molti in Asia orientale.
Quella post-Covid è una Cina “diversa”. A ottobre, il XX Congresso del Partito comunista ha ufficializzato un riassetto in corso da mesi. La promozione (nonostante i 69 anni suonati) dell’ex ministro degli Esteri, Wang Yi, a capo della Commissione Esteri del Partito Comunista (la carica diplomatica più autorevole, in Cina), e l’arrivo alla guida del dicastero dell’ex ambasciatore negli Stati Uniti, Qin Gang, hanno coinciso con una ridefinizione della strategia estera di Pechino. Da una parte è emerso il tentativo di adottare un approccio vagamente più conciliante nei confronti dei Paesi ritenuti meno ostili: l’uscita di scena di alcuni “lupi guerrieri” (i diplomatici cinesi più oltranzisti), la ripresa dei colloqui con l’Unione Europea, e un linguaggio più morbido nei confronti di Taiwan, sono interpretabili come segnali distensivi, se rapportati alle provocazioni degli ultimi tre anni. Dall’altra parte, si è fatta strada l’esigenza di puntare di più sulle amicizie già consolidate. Pur rifuggendo le alleanze in senso proprio, storicamente – soprattutto in Africa – la Cina vanta una nutrita schiera di sodali accomunati da un doloroso passato coloniale e una forte voglia di rivalsa nei confronti dell’Occidente.
Da sempre la politica estera cinese viene considerata un’appendice dell’agenda interna e come tale riflette gli obiettivi nazionali del Partito-Stato. E’ tanto più vero sotto la guida centralizzata di Xi, che non lascia quasi nessuno spazio all’iniziativa personale di altre figure. Non sono Wang e Qin a modificare la politica estera cinese. Piuttosto “è la leadership centrale ad averli scelti come esecutori della propria linea politica all’estero”, ci spiega Enrico Fardella, direttore del ChinaMed Project presso l’Università di Torino.
La direzione intrapresa è abbastanza chiara. Il pensionamento dell’”americanista”, cioè più ferrato sulla politica statunitense, Yang Jiechi, e la promozione di Wang, un esperto di affari asiatici, lasciano presagire un crescente interessamento di Pechino per le potenze emergenti. E’ qui che la Cina ha la possibilità di raccogliere consensi giocabili in sede ONU per far valere gli interessi nazionali. Certo, sul medio-lungo termine ricucire i rapporti con gli Stati europei europee resta una priorità, per respingere efficacemente il pressing americano che punta all’isolamento di Pechino anche in chiave economica. Ma è in Africa, Oceania e America Latina che Pechino può ottenere supporto immediato contro Washington. Anche nell’ottica di un maggiore protagonismo nella definizione dei futuri assetti internazionali. Secondo il South China Morning Post, oltre la metà degli incontri ufficiali dall’inizio del mandato di Qin hanno coinvolto funzionari di Paesi in via di sviluppo.
Proprio a questo gruppo di Paesi si rivolgono la Global Development Initiative (GDI), la Global Security Initiative (GSI), e la Global Civilization Initiative (GCI), le tree nuove azioni di politica estera che a partire dal settembre 2021 hanno affiancato la famigerata Belt and Road Initiative (BRI). Colpito dal Covid-19 e seppellito dai debiti, negli ultimi anni il mega-progetto infrastrutturale cinese ha perso velocità. Da qui la necessità di spostare gli sforzi dalla costruzione di strade, ponti e ferrovie, all’esportazione di “visioni”. Dall’hardware al software. Prima l’annuncio di una Conferenza di pace in Etiopia, poi il “position paper” sulla guerra russo-ucraina, dimostrano come, vestendo i panni del mediatore nelle controversie internazionali, Pechino ambisca a elevare il proprio ruolo internazionale. Dopo il lavoro sporco nei cantieri di mezzo mondo, la Cina ora non vuole più solo fornire mezzi materiali. Vuole produrre nuove idee e soluzioni di sviluppo globali.
Per quanto in parte di natura “cosmetica” (e senza un impatto concreto), le due iniziative di pace rispondono a un’esigenza reale. Buona parte delle economie emergenti non si riconoscono nel modello propugnato dall’Occidente. Quello a cui punta Pechino – come spiega il People’s Daily, organo del Partito – è proporre un paradigma “diverso dalla modernizzazione promossa da alcuni Paesi che hanno invaso, colonizzato e saccheggiato, causando grandi sofferenze alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo.” – e che dunque non avrebbero legittimità per proporre il proprio ordine internazionale. La GDI e la GSI promettono proprio questo: promettono di portare sviluppo senza compromettere la sovranità di nessuno, e assicurare stabilità sociale attraverso l’emancipazione economica. Il tutto – come rimarcato nei comunicati ufficiali – nel rispetto dei principi delle Nazioni Unite.
Il nesso tra hardware e software, tra benessere materiale e influenza politica, tra sviluppo economico e sicurezza nazionale, ritorna nelle parole di Yang Ping, caporedattore della popolare rivista Beijing Cultural Review, che recentemente ha invitato a valutare la BRI per il suo potenziale strategico, “oltre che per il mero business“ e “per esportare capacità produttiva”. Secondo Yang, anche in assenza di un ritorno economico, ci sono Paesi dove conviene ugualmente investire per accrescere la propria influenza. Senza giri di parole il giornalista si riferisce alla necessità di costruire “un nuovo ordine internazionale”: ed è “a Sud che bisogna guardare”.
Questa maggiore assertività di Pechino sta creando non poche contorsioni all’interno della diplomazia cinese. Come conciliare il crescente protagonismo oltre confine con il principio tradizionalmente propugnato dalla Cina della non ingerenza negli affari degli altri Paesi? Dagli anni ‘50, la Cina ha sempre schivato un coinvolgimento nei conflitti e nelle dispute locali. Eppure, ultimamente, la tradizionale politica della “coesistenza pacifica” è stata messa a dura prova dalla necessità di dimostrare una maggiore propositività nella risoluzione delle grandi crisi internazionali. I primi vacillamenti sono avvenuti in Medio Oriente, l’unica regione a cui – con l’Africa, il Sud Est asiatico e le isole del Pacifico –– è dedicata una sezione ad hoc nel Global Security Initiative Concept Paper.
Per anni i rapporti tra la Cina e gli stati del Golfo sono rimasti soprattutto circoscritti al settore energetico. Ma il crescente interesse per la cooperazione tecnologica ha incentivato una maggiore permeabilità della popolazione locale al “soft power” cinese: sebbene i marchi occidentali siano ancora popolari, anche in Medio Oriente i giovani cominciano a guidare auto Geely, utilizzano telefoni Huawei, creano video su TikTok, e comprano su Aliexpress, servizio cinese di e-commerce per acquirenti internazionali. Prima si esportano i dispositivi, poi quelle idee, quelle visioni, che Pechino cerca di promuovere fuori dai confini nazionali.
Separare l’economia dalla politica diventa sempre più difficile. Soprattutto nei Paesi storicamente sotto l’influenza americana (come Arabia Saudita e Israele), e ora chiamati da Washington a fare una scelta di campo. Ottenere il loro supporto può richiedere a Pechino qualche deviazione dalla consueta non ingerenza. L’intercessione cinese nella normalizzazione dei rapporti tra Arabia Saudita e Iran costituisce un chiaro esempio di questa nuova assertività, ma non l’unico. Recentemente ha fatto molto discutere la dichiarazione congiunta rilasciata al termine dell’incontro tra Xi e i leader arabi a Riad, in cui è comparso un riferimento alle rivendicazioni emiratine su alcune isole contese con l’Iran.
Mentre diversi analisti hanno sminuito l’accaduto attribuendolo a un errore di traduzione, l’insolita imprudenza del leader cinese non solo ha indisposto Teheran, tanto da aver reso necessaria una convocazione dell’ambasciatore cinese nel paese. Ha anche dato adito al sospetto di un premeditato cambio di strategia. La volontarietà della provocazione resta da appurare, ma non si tratta di un caso isolato. A stretto giro sono arrivate dalla Cina le accuse frontali contro Israele, chiamato lo scorso gennaio a “fermare immediatamente ogni istigazione [alla violenza]” in Palestina e ad accettare una “soluzione dei due Stati”. Come per l’Ucraina, Pechino, pur proponendo di mediare, in realtà appoggia chiaramente una delle parti in causa.
“Dopo la crisi del 2008 avviata dal fallimento di Lehman Brothers è cresciuta la fiducia cinese nelle proprie possibilità materiali e immateriali e il Medio Oriente è diventato un laboratorio per testare iniziative di politica estera più ‘creative’, come vengono definite”, ci spiega Enrico Fardella. “Per quanto riguarda i temi delle isole contese nel Golfo Persico, a mio parere ciò dimostra che Pechino sente di avere una leva abbastanza forte per ‘gestire’ i rapporti con l’lran approfittando della sua ‘fragilità’ – e dunque della crescente ‘dipendenza’ di Teheran da Pechino e Mosca. Se la Cina riuscisse a moderare le istanze destabilizzanti dell’Iran nella regione, rafforzerebbe il proprio prestigio nel mondo arabo,” afferma il professore.
Così facendo la Cina crea dei precedenti utili per puntellare la GSI, ma anche per tutelare le proprie posizioni nel Mar Cinese Meridionale, dove Pechino è a sua volta coinvolta in dispute territoriali con i Paesi rivieraschi. Ma stesso vale per la questione palestinese. Negli ultimi due anni le minacce di sanzioni americane hanno inibito gli investimenti cinesi in Israele, scesi ad appena l’1% di quanto raccolto dalle startup tecnologiche locali nel 2021.
Parlare di una “svolta” tuttavia potrebbe essere inopportuno. Secondo Fardella, infatti, “la Cina non ha mai realmente praticato la ’non ingerenza’ come la intendiamo noi. Il punto ora sta nel rendere il principio più flessibile, senza legarlo alla tutela di un diritto oggettivo internazionale, perché possa servire i mutati interessi soggettivi di sicurezza nazionale.” Pechino non ritiene più di doverlo nascondere.
Di Alessandra Colarizi
[Pubblicato su Aspenia]
Classe ’84, romana doc. Direttrice editoriale di China Files. Nel 2010 si laurea con lode in lingua e cultura cinese presso la facoltà di Studi Orientali (La Sapienza). Appena terminati gli studi tra Roma e Pechino, comincia a muovere i primi passi nel giornalismo presso le redazioni di Agi e Xinhua. Oggi scrive di Cina e Asia per diverse testate, tra le quali Il Fatto Quotidiano, Milano Finanza e il Messaggero. Ha realizzato diversi reportage dall’Asia Centrale, dove ha effettuato ricerche sul progetto Belt and Road Initiative. È autrice di Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro.