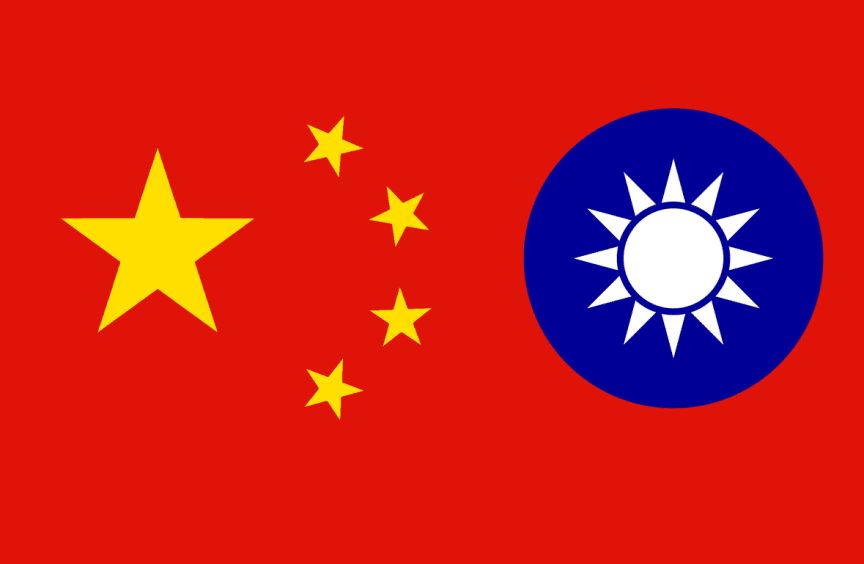L’esercito cinese ha annunciato quest’oggi che interromperà le esercitazioni militari intorno a Taiwan, ma i pattugliamenti regolari proseguiranno. Passati diversi giorni dalla partenza di Pelosi dall’isola, Pechino non sembra intenzionata ad allentare la pressione. Troppi gli interessi politici ed economici in gioco. Ma non è detto siano prove ufficiali di un’invasione. Proprio stamattina il Consiglio di Stato cinese ha rilasciato un libro bianco sulla questione taiwanese che utilizza toni concilianti: “”Lavoreremo con la massima sincerità ed eserciteremo i nostri maggiori sforzi per ottenere una riunificazione pacifica”.
7 agosto, ore 12.00: Quel giorno a quell’ora, la Cina avrebbe dovuto terminare le massicce esercitazioni militari in risposta alla visita di Nancy Pelosi a Taiwan. Avrebbe dovuto, sì, perché smentendo i piani iniziali caccia e navi da guerra cinesi continuano a circondare l’isola. Le operazioni nello Stretto proseguiranno, ha annunciato lunedì 8 agosto il Comando del teatro orientale cinese, senza fornire altri dettagli.
A cinque giorni dalla partenza di Pelosi dall’isola, Pechino non sembra dunque intenzionata ad allentare la pressione su Taiwan. Troppi gli interessi politici ed economici in gioco. Troppi i rischi reputazionali di una resa precoce. La cosiddetta “quarta crisi dello Stretto” ha infatti varie chiavi di lettura. Può essere considerata una questione economica: Taiwan fornisce una fetta consistente delle importazioni cinesi di semiconduttori, assicurando una componentistica sempre più difficile da ottenere a causa delle sanzioni americane. Pechino vede con sospetto le manovre legislative con cui Washington corteggia i colossi dei microchip taiwanesi, e teme di rimanere a secco di forniture.
Può essere inoltre letta in chiave geostrategica: la mastodontica mobilitazione dei mezzi militari cinesi pare voler contestare piuttosto apertamente gli equilibri regionali eterodiretti da Washington, da Pearl Harbour in poi: Taiwan viene considerata la pietra angolare della “prima catena di isole”, ossia quel cordone di sicurezza creato dagli USA in tandem con gli alleati asiatici per contenere la Cina. Così, l’avvio di contatti di alto profilo tra Washington e Taipei (pur in assenza di relazioni ufficiali) viene visto con sospetto a Pechino alla luce del rinnovato interesse americano per i vecchi sodalizi asiatici.
Ma, come rimarcato dalla stampa cinese, è soprattutto la politica interna a giustificare la risposta muscolare di Pechino. Secondo il Quotidiano del Popolo, megafono del partito comunista cinese, le misure adottate “dimostrano che la Cina è determinata e pienamente in grado di tutelare l’unità nazionale e salvaguardare […] la sovranità e l’integrità territoriale”. E’ un avvertimento agli USA, ma anche un monito per tutti quei Paesi che occhieggiano le iniziative anti-cinesi di Washington nell’Indo-Pacifico.
Proprio su quelle stesse colonne, a luglio Liu Jieyi, direttore dell’Ufficio cinese per gli Affari di Taiwan, ha inserito il tema della riunificazione nell’alveo della “rinascita nazionale”. Il messaggio è chiaro: sul lungo periodo anche l’indipendenza de facto rende l’isola un ostacolo verso il “chinese dream” e il riscatto finale dell’ex Celeste Impero dalle umiliazioni subite nell’Ottocento per mano degli invasori occidentali. Senza contare che l’esistenza di una “Cina democratica” rischia di delegittimare la Cina comunista su uno scacchiere internazionale sempre più ideologizzato. “Today the world faces a choice between democracy and autocracy”, spiegava Pelosi incontrando la presidente taiwanese Tsai Ing-wen.
Quello della democrazia è un tema molto sentito anche nella Repubblica popolare, dove i policymaker hanno confutato la paternità occidentale del termine fornendone un’interpretazione “marxista-confuciana”. Già nel 2005 Jiang Shigong, docente della Peking University Law School, spiegava che “Taiwan non è solo una questione politica, ma anche ideologica”. Il motivo è che, oltre a interessare l’ascesa internazionale della Cina, le sorti dell’isola riguardano “il futuro dell’umanità”. “Se la Cina vuole resuscitare la sua civiltà tradizionale,” avvertiva l’esperto, “deve ottenere la leadership politica nell’Asia orientale”; obiettivo raggiungibile solo dopo la riunificazione con Taiwan.
Negli anni Duemila, la l’orientamento filocinese del Guomindang (KMT), partito al governo a Taipei, aveva avviato una fase distensiva tra le due sponde dello Stretto, chiusa però dopo la vittoria della progressista Tsai Ing-wen alle elezioni presidenziali del 2016. Contestualmente, in Cina, la nomina di Xi Jinping a segretario del partito ha coinciso con una sterzata ideologica dopo due decenni all’insegna dell’”arricchimento glorioso”, caratterizzato da visioni ideologiche più pragmatiche e sfumate.
Cresciuto politicamente nel Fujian, la provincia con affaccio sullo Stretto di Formosa, Xi è particolarmente sensibile al tema della riunificazione: figlio di uno degli eroi della rivoluzione comunista cinese, è legato alle vicende taiwanesi dal nonno materno, Qi Houzhi, dirigente del braccio armato del KMT durante la spedizione del Nord avviata per combattere i signori della guerra e riportare ordine nel paese dopo la caduta dell’ultima dinastia. L’approssimarsi del XX Congresso del Partito, quando – salvo imprevisti – in autunno Xi otterrà un terzo mandato, accresce l’impatto potenzialmente destabilizzante della visita di Pelosi.
Il presidentissimo non può permettersi di apparire debole davanti alle provocazioni americane. Secondo Jude Blanchette, politologo del Center for Strategic and International Studies di Washington, anche in caso di riconferma alla guida del partito, “Xi non sarebbe in grado di governare efficacemente senza il forte sostegno dei capi provinciali del partito e soprattutto delle forze armate”. Se, come diceva Mao, “il potere politico nasce dalla canna del fucile”, il mancato supporto in alcuni ambienti potrebbe ripercuotersi sulla composizione interna del prossimo Comitato centrale del partito, privando il leader di preziosi alleati.
Ma le mosse del presidente non devono passare solo attraverso il giudizio dei colleghi. Sui social media la visita è diventata immediatamente trending topic, accompagnata dallo sdegno dei cinesi per una reazione considerata troppo morbida, a dimostrazione di come soffiare sul fuoco del nazionalismo può rivelarsi un’arma a doppio taglio: serve abilità funambolica per soddisfare le aspettative dei patrioti cinesi senza rischiare una guerra calda con Washington. Il disagio dell’establishment ha raggiunto le colonne del Quotidiano del Popolo, dove le esercitazioni militari sono state retrocesse a pagina tre per tutta la durata delle operazioni.
Occorre tenere in considerazione un ultimo elemento. La reazione bellicosa di Pechino è anche il prodotto di un senso di insicurezza che nella “Nuova Era” di Xi ha raggiunto nuovi livelli record. Riferimenti al timore di una “rivoluzione colorata” riempiono quasi quotidianamente la stampa statale.
Commentando la visita di Pelosi, il ministero degli Esteri cinese ha accusato Washington di voler giocare la “carta di Taiwan per contenere la Cina”. “La tattica abituale degli Stati Uniti è che prima creano i problemi e poi li usano per raggiungere i loro obiettivi. Ma questo approccio non funzionerà con la Cina”, ha articolato nel fine settimana il titolare del dicastero, Wang Yi. Il “jolly” in questione si chiama Taiwan Policy Act, bozza al vaglio del Congresso che punta a elevare i rapporti con Taipei oltre i limiti imposti dal Taiwan Relations Act, il documento che regola le sinergie bilaterali dal 1979.
Mentre permane il dubbio che Pechino possa sfruttare la crisi per testare le reali capacità difensive di Taipei, va riconosciuto che fino a pochi giorni fa la prospettiva di un’imminente annessione manu militari non sembrava nei piani cinesi. Tratteggiando una prima strategia, nel suo articolo Liu Jieyi ha parlato di “riunificazione pacifica” citando espressamente il principio “un paese, due sistemi”, la politica adottata a Hong Kong dopo l’handover, ma che i taiwanesi, anche i nazionalisti del KMT, respingono categoricamente. Il libro bianco “The Taiwan Question and China’s Reunification in the New Era”, pubblicato il 10 agosto, in piena crisi, ribadisce con toni concilianti buona parte di quanto assicurato in precedenza. Qualcosa di più chiaro potrebbe emergere durante il Congresso, quando è atteso l’annuncio di un documento programmatico per risolvere una volta per tutte la questione taiwanese.
Resta sullo sfondo l’incognita delle presidenziali del 2024. Se la speranza è l’ultima a morire, non è escluso che Pechino auspichi ancora un ritorno al potere degli amici del Guomindang. Ma, se così non fosse, cosa farà Xi? Secondo gli analisti, le ritorsioni economiche degli ultimi anni e le intimidazioni militari in corso, anziché servire da edulcorante, hanno ulteriormente compromesso l’immagine della “madrepatria” tra l’elettorato taiwanese.
Il tempo stringe. Nel mese di luglio, il Consiglio di Stato cinese ha divulgato un piano che prevede la costruzione entro il 2035 di un’autostrada e una ferrovia ad alta velocità per collegare Pechino con Taiwan, passando per Fuzhou, nella provincia sudorientale del Fujian. Allora l’isola dovrà necessariamente essere tornata alla terraferma. Con la diplomazia o con i missili.
Di Alessandra Colarizi
[Pubblicato su Aspenia]
Classe ’84, romana doc. Direttrice editoriale di China Files. Nel 2010 si laurea con lode in lingua e cultura cinese presso la facoltà di Studi Orientali (La Sapienza). Appena terminati gli studi tra Roma e Pechino, comincia a muovere i primi passi nel giornalismo presso le redazioni di Agi e Xinhua. Oggi scrive di Cina e Asia per diverse testate, tra le quali Il Fatto Quotidiano, Milano Finanza e il Messaggero. Ha realizzato diversi reportage dall’Asia Centrale, dove ha effettuato ricerche sul progetto Belt and Road Initiative. È autrice di Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro.