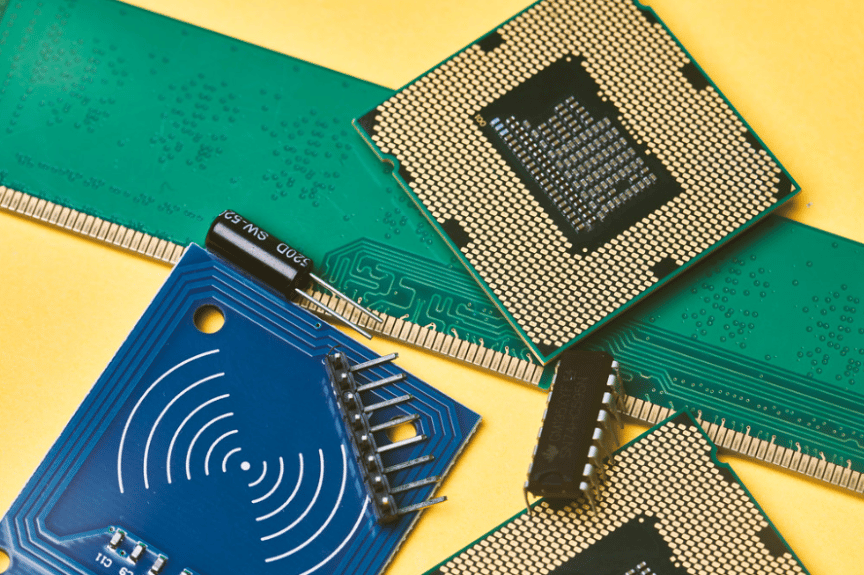Tutto è cominciato il 7 ottobre, quando l’amministrazione Biden ha annunciato nuove restrizioni sull’export di tecnologia avanzata verso la Cina. Pechino parla di “bullismo tecnologico”, ma a essere colpite non sarebbero solo le compagnie cinesi. Secondo Bloomberg, la scorsa settimana il ministero dell’Informazione e dell’It cinese ha convocato d’urgenza i campioni nazionali per valutare l’impatto delle nuove misure americane.
Le tensioni tra Cina e Stati Uniti stanno creando “sfide più severe” per l’industria dei semiconduttori. Il presidente del colosso tecnologico Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) lo dice senza giri di parole. La “chip war” tra Pechino e Washington rischia di avere effetti globali. Mark Liu non lo afferma esplicitamente ma l’origine delle preoccupazioni è chiara: le ultime misure annunciate dall’amministrazione Biden per contenere l’ascesa tecnologica della Cina avranno un effetto domino sulla filiera mondiale. Una filiera di cui Taiwan rappresenta uno snodo cruciale.
Tutto è cominciato il 7 ottobre, quando con una manovra a tenaglia l’Ufficio per l’industria e la sicurezza (BIS), costola del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, ha annunciato a stretto giro l’inserimento di altre 31 entità cinesi nella lista delle aziende “non verificate” (anticamera della entity list che preclude l’accesso alle forniture americane), oltre a nuove restrizioni sull’export di tecnologia avanzata verso la Cina: nello specifico il ban interessa i chip informatici di fascia alta, la tecnologia necessaria a sviluppare e mantenere supercomputer e i macchinari utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori avanzati con potenziali applicazioni militari e di controllo sociale. Coinvolti non sono solo i prodotti Made in Usa, ma anche la componentistica fabbricata in altre parti del mondo se nel processo produttivo sono impiegati macchinari americani. Alle aziende e ai cittadini statunitensi è stato inoltre vietato di fornire qualsiasi tipo di supporto diretto o indiretto agli impianti di produzione di semiconduttori in Cina.
Se applicate alla lettera, le nuove misure assesteranno un colpo mortale all’industria cinese dei semiconduttori e ai piani di sviluppo di Pechino. Per il ministero degli Esteri cinese si tratta di “bullismo tecnologico”. Ormai da tempo la leadership di Xi Jinping è convinta che l’obiettivo degli Stati Uniti non sia difendere la sicurezza nazionale, bensì prevenire il sorpasso economico della Cina. Una prospettiva che fino a poco tempo fa Bloomberg e HSBC proiettavano poco dopo il 2030.
Mentre servirà del tempo per soppesare con cura le ripercussioni degli ultimi provvedimenti, gli analisti internazionali concordano nel giudicare la manovra di Biden “un’escalation”: un conto è colpire singole aziende, come ha fatto Donald Trump con Huawei e ZTE, un altro è invece applicare restrizioni generalizzate su tutto il settore. La Cina consuma più di tre quarti dei semiconduttori venduti a livello globale, ma conta solo per il 15% circa della produzione mondiale. Per compensare le proprie mancanze, la seconda potenza mondiale si rivolge principalmente a Corea del Sud, Paesi Bassi e Taiwan, che da sola soddisfa il 90% della domanda mondiale di chip avanzati. Ma che a sua volta fa ampio uso di tecnologia americana.
Questo vuol dire che l’onda d’urto rischia di abbattersi anche sui produttori asiatici, fortemente dipendenti dai processori statunitensi. Non per nulla i tentativi di Washington di istituire un’alleanza transpacifica dei chip (la Chip 4) in chiave “anti-cinese” sinora hanno incontrato una risposta tiepida sul lato asiatico dell’Oceano. Solo pochi giorni fa, il Ceo di TSMC, C.C. Wei, ha annunciato che il colosso taiwanese ha ottenuto una licenza che gli permetterà di continuare a operare in Cina per un anno, nonostante le direttive di Biden. Lo stesso è avvenuto con la sudcoreana SK Hynix. Ma restano validi i divieti sulla cooperazione tra TSMC e i giganti americani Nvidia e Advanced Micro Devices nel mercato cinese. Ergo, anche i campioni nazionali pagheranno a caro prezzo la stretta protezionistica di Washington.
Secondo ICwise, la Cina è il primo mercato per tre dei maggiori fornitori statunitensi di apparecchiature per semiconduttori, rappresentando il 33% delle entrate di Applied Materials Inc., il 35% di Lam Research Corp. e il 26% di KLA Corp. Nel 2020, all’acme della trade war tra le due superpotenze, una ricerca condotta da SIA e Boston Consulting Group stimava che un divieto totale delle vendite di semiconduttori ai partner cinesi ridurrebbe del 37% le entrate delle aziende statunitensi.
Solo pochi giorni fa, secondo fonti del Nikkei, Apple avrebbe sospeso i rapporti con la Yangtze Memory Technologies (YMTC), il gigante cinese dei chip finito nella “unverified list” e a cui il colosso di Cupertino aveva intenzione di commissionare le memorie NAND flash per i suoi iPhone. La decisione, se confermata, sancisce un ulteriore allontanamento della mela morsicata dalla Cina, dopo le recenti indiscrezioni riguardo l’apertura di fabbriche in India e Vietnam per la produzione di smartphone, Apple Watch, e MacBook. La delocalizzazione nel Sud dell’Asia segue le frequenti interruzioni della produzione a causa della ferrea strategia Zero Covid applicata dal governo cinese per contenere l’epidemia da coronavirus e che ha costretto diverse multinazionali ad adottare protocolli di emergenza. Ma è chiaro che la scelta tiene ugualmente conto della guerra commerciale con Washington e delle sue tentacolari diramazioni.
La Cina, dal canto suo, è dal 2014 che persegue la strategia dell’autosufficienza come meglio sa fare: ovvero iniettando sussidi statali nel settore. Grazie al supporto del governo, Shanghai e Shenzhen puntano a diventare le locomotrici della ricerca e dell’innovazione mondiale. Ma per il fondatore di TSMC, Morris Chang, ci vorranno almeno cinque anni prima che la Cina possa competere alla pari con Taiwan e la Corea del Sud nella produzione di chip avanzati. E la strada non è solo lunga. Come spesso avviene nei progetti calati dall’alto, è anche lastricata di casi di corruzione, contrabbando, e storie di insuccesso: secondo il South China Morning Post, 3.470 società cinesi dei microchip sono fallite dall’inizio dell’anno, il numero più alto di sempre.
Di Alessandra Colarizi
[Pubblicato su Il Fatto quotidiano]
Classe ’84, romana doc. Direttrice editoriale di China Files. Nel 2010 si laurea con lode in lingua e cultura cinese presso la facoltà di Studi Orientali (La Sapienza). Appena terminati gli studi tra Roma e Pechino, comincia a muovere i primi passi nel giornalismo presso le redazioni di Agi e Xinhua. Oggi scrive di Cina e Asia per diverse testate, tra le quali Il Fatto Quotidiano, Milano Finanza e il Messaggero. Ha realizzato diversi reportage dall’Asia Centrale, dove ha effettuato ricerche sul progetto Belt and Road Initiative. È autrice di Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro.