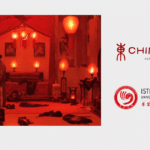Gong Li è il volto internazionale del cinema cinese, la diva di Zhang Yimou, simbolo di una Cina “che non c’è”. Una lunga analisi per raccontare la nascita e le trasformazioni di una dellepiù note dive del grande schermo
Tra Sorgo rosso e La Triade di Shanghai si afferma l’immagine della diva Gong Li, sconosciuta studentessa del Central Drama Academy di Pechino, diventata in poco meno di un decennio il volto nuovo e internazionale del cinema cinese. Più di un regista collabora al suo lancio (non ultimo Chen Kaige con un melodramma di forte impatto come Addio mia concubina del 1993), ma essenziale è stato in proposito, il ruolo di Zhang Yimou. Dal loro sodalizio artistico nasce una star inedita e problematica che rappresenta, attraverso un’ampia gamma di ruoli, con prospettive e sfumature diverse, il destino storico della donna cinese ma anche il suo profondo desiderio di identità e di affrancamento da norme e rituali secolari. Può darsi che Zhang Yimou abbia spesso inteso guadagnarsi con i suoi film l’attenzione e il compiacimento del pubblico occidentale, come da più parti gli è stato rimproverato, magari divulgando stereotipi o volgarizzando la cultura del proprio paese attraverso “l’ostentazione di icone e simboli di una Cina affascinante ma in realtà inesistente”.1 Fatto sta che i personaggi femminili ritagliati dal regista per Gong Li, la cui bellezza non mette affatto in ombra le sue performance e capacità artistiche, rappresentano nella maggior parte dei casi donne forti, tenaci che cercano di difendersi dal predominio del mondo maschile preferendo non di rado soccombere piuttosto che rinunciare a se stesse e alle proprie pulsioni vitali. Basti pensare a figure come la studentessa Songlian in Lanterne rosse, quarta moglie inappagata di un signore feudale, o come la bella Ju Dou nel film omonimo, moglie di un vecchio e brutale tintore, o anche la contadina gravida nella Storia di Qiu Ju, che esige soddisfazione per il marito maltrattato dal capovillaggio e non esita a sobbarcarsi ripetuti ed inutili viaggi fino a Pechino per far valere non solo i propri diritti ma l’idea stessa di giustizia.2 Si tratta di sconsolati ritratti di donne umiliate e sconfitte alle prese con la violenza e il potere, con il peso soffocante di una tradizione sostanzialmente feudale, insensibile e distruttiva. Vicende e immagini si contemperano traducendo il volto di Gong Li in primi piani su cui il suo regista ha lavorato con febbrile attenzione: come se proprio nel suo sguardo l’oppressione umana e sociale e il dolore subito si consolidassero in una sorta di bellezza marmorea, misteriosa e perfetta. Un volto che ha espresso il difficile destino della donna cinese nelle sfumature del coraggio e della disperazione fino alla latente tensione dell’odio come nella Città proibita e che non di rado assume nelle intenzioni di Zhang Yimou valenze più complesse. Come nel suo primo film del 1987, Sorgo rosso, vincitore dell’Orso d’oro al Festival di Berlino con la storia di una ragazza degli anni Venti data in sposa al padrone lebbroso di una distilleria di sorgo in cambio di un mulo, la quale si oppone al proprio destino innamorandosi di un prestante operaio. Potere e tradizione, in questo caso, sembrano rubricate dal regista fra tutto ciò che è repellente e malato; mentre la rivolta, la ribellione oltreché moralmente apprezzabili in un sistema oppressivo, riflettono la bellezza del volto di Gong Li aperto alla speranza, se non proprio alla gioia, di un possibile riscatto.
Forse non è un caso che nella vita, lontana dallo schermo che col tempo l’ha promossa a sex-symbol del suo paese, la diva abbia riequilibrato quei ruoli e quei destini con l’affermazione di doti e capacità sottratte all’imperativo categorico di una tradizione opaca e indifferente e oggi soprattutto al gioco e alla manipolazione dei media, studiando sociologia all’Università di Pechino e concludendo la sua specializzazione con un master nel 2000, pochi anni dopo il suo matrimonio. La donna indipendente, consapevole e volitiva sembra confermare nella propria esperienza privata il messaggio di emancipazione che la sua immagine artistica ha diffuso tra Oriente e Occidente. Certo anche lei ha dovuto destreggiarsi fra i burocrati della censura in una Cina dove da tempo è considerata una superstar e dove sul piano politico, a suo parere, dovrebbero cambiare non poche cose: una situazione non facile con cui ha trovato modo di convivere soprattutto grazie al suo successo internazionale e all’immagine molto apprezzata dagli alti papaveri in film come L’ imperatore e l’assassino di Chen Kaige o la stessa Città proibita, che ha segnato nel 2007 la ripresa della sua collaborazione con Zhang Yimou. Opere che mettono in luce violenze e contraddizioni nella millenaria storia cinese ma sempre con l’obiettivo, legato forse ad un certo ammorbidimento politico dei registi della quinta generazione a favore di compiacimenti estetizzanti, di esaltare e incensare la nascita del Grande Impero. In quel contesto l’icona di Gong Li ha funzionato benissimo, anche quando lei indossa la maschera della vendetta e sembra scaturire da un dramma shakespeariano più che dal laboratorio scenico della tradizione locale.
Nel frattempo anche i politici hanno dovuto riconoscere in lei il prototipo della donna moderna che il mondo apprezza ed esalta: è bella, ha successo, per di più è cauta e moderata nelle sue critiche al regime e moglie di un imprenditore da più di un decennio. E il mondo della globalizzazione, soprattutto a Hollywood, non si è lasciato scappare l’occasione cogliendo purtroppo solo gli aspetti più epidermici del fenomeno e cercando di sfruttare, in verità nel modo più discutibile e banale, il feticcio della donna orientale.
Gong Li fa il grande salto nel cinema americano all’inizio degli anni 2000 con tre blockbuster che non ne hanno certo migliorato né affinato l’immagine3. In realtà un primo tentativo con il regista sino-americano Wayne Wang nella pellicola del 1997 Chinese Box non ebbe il successo sperato. Qui l’attrice fa la parte di Vivian, ex spogliarellista e misteriosa lady dell’ambiente del malaffare (il legame con la malavita si ripresenta nel 2006 in Miami Vice di Michael Mann) coinvolta in una storia d’amore con un giornalista inglese (Jeremy Irons) che si aggira per Hong Kong con la sua videocamera nel momento in cui la città sta per passare al governo cinese. Wang non riuscì a ripetere il successo di Smoke, dove si era potuto giovare della sceneggiatura dello scrittore Paul Auster intrecciando storie di vita quotidiana intorno alla bottega del tabaccaio-filosofo Auggie Wren.
Al di là del singolo film resta tuttavia il problema di fondo: il dilettantismo e la miopia che Hollywood ha sempre mostrato nei confronti delle dive orientali, incapace di coglierne e sfruttarne la loro specifica identità. Anche Gong Li non ha fatto eccezione. Mentre Zhang Yimou rivoltava la storia cinese dei primi decenni del Novecento declinando al tempo stesso sentimenti e pulsioni come preziosi frammenti di una storia della sessualità inquinata e imbarbarita dal potere e da secoli di sopraffazione maschile, Hollywood miscela ogni cosa in film di genere il cui solo scopo sembra essere quello di stupire, sopraffare emotivamente o sedurre il pubblico ricorrendo ai mezzi più improbabili: dall’horror alla violenza gratuita, dall’azione parossistica fine a se stessa ai mille stereotipi di un insipido esotismo.
I film cinesi di Zhang Yimou, come già si è visto, sono strettamente legati alla figura dell’attrice, cuore pulsante di vicende aperte sulle infinite contraddizioni di una potenza radicata nei millenni, a mezza strada tra una figura verosimile, specchio di precise realtà storiche, e una sorta di divinità dello schermo, intorno a cui si arrovellano e infrangono cuori maschili. Un’icona ormai sedimentata nell’immaginario collettivo e plasmata dall’intelligenza di un regista che ha saputo fare della bellezza l’occasione per riflettere sul moderno concetto dell’erotismo, a cui la tradizionale società cinese lascia poche chance, e sulle dinamiche del desiderio affrancato da secolari incrostazioni e rimozioni. Del resto anche Zhang Yimou non è stato indenne da certi vizi utilizzando canovacci tradizionali, come il gangster-movie ne La triade di Shanghai, per rilanciare la sua attrice preferita in una forma del tutto stilizzata. Non a caso in quel contesto Gong Li sembra rifarsi, come si è visto, alle dive del passato: il regista ha giocato sulla sua immagine ormai accreditata, su un certo virtuale cliché, facendo sì che ella stessa si mettesse in scena come mito cinematografico. Il richiamo al passato cattura tutta l’aura possibile che l’immaginazione visiva collega, ad esempio, ad una figura come Marlene Dietrich ai tempi di Lola-Lola. E il suo mito ha finito per contagiare anche l’America, dove tuttavia il salto di Gong Li nell’élite hollywoodiana non è ancora del tutto riuscito né sembra configurarsi come un’attrazione fatale per l’attrice che vive fra Hong Kong e Pechino. È pur vero che i ruoli interpretati per gli studi americani, anche se non nelle vesti di cinese, costituiscono una variante e pur sempre una sfida, come lei stessa ha dichiarato, nei confronti del suo repertorio tradizionale. Nulla tuttavia al confronto con i personaggi e le sceneggiature proposte dai suoi connazionali, non ultimo il grande Wong Kar-wai, il regista di In the Mood for love, col quale, poco prima dell’esperienza sui set americani, Gong Li girò l’intrigante film 2046, labirintica e struggente rappresentazione di un’ossessione sentimentale cadenzata sullo “stream of consciousness” di letteraria memoria (da Proust alla Woolf). Nei panni di Su Lizhen, una sorta di revenante che ricorda al giornalista Chow Mo-wan la donna amata a Hong Kong da cui si era separato dolorosamente, Gong Li riacquista in questa seducente prova un ruolo centrale guidando il protagonista oltre gli smarrimenti e i fantasmi sentimentali e suggellando in tal modo il suo trionfale ritorno sulla scena internazionale.
Ma il mondo hollywoodiano aveva in serbo ben altre cose per la superdiva del cinema cinese. A dir poco, il ribaltamento della sua identità come star e come persona nel film Memorie di una geisha (2005) i Rob Marshall che nel 2002 aveva ricevuto l’Oscar per il musical Chicago. Tratta dal romanzo di Arthur Golden la pellicola è inficiata da un grave vizio d’origine fra faciloneria, sconsideratezza e caricatura razzista. Proprio una figura così tradizionale della cultura giapponese come la geisha, il cui mito di donna sottomessa e “curatrice” del piacere si è riflesso anche in una certa modernità occidentale alle prese con l’avanzata del femminismo, viene rappresentato da star cinesi come la giovane Zhang Ziyi, la nuova stella del regista Zhang Yimou, qui nel ruolo di protagonista, e dalla stessa Gong Li che interpreta l’aggressiva e invidiosa geisha Hatsumomo, a cui Marshall ha pensato bene di affiancare anche la malese Micelle Yeoh, provetta spadaccina assieme a Ziyi nel sontuoso film d’azione La tigre e il dragone di Ang Lee. Inutile dire che le critiche non si sono fatte aspettare: il film scaturito dalla biografia rivisitata della leggendaria geisha Mineko Iwasaki ha irritato, com’era facile prevedere, i cultori nipponici di patrii miti; ma non ha certo lasciato indifferenti i critici cinesi pronti a demonizzare in primo luogo la protagonista, la piccola Chiyo, che a nove anni – come racconta lei stessa in età avanzata con voce fuori campo – fu costretta a lasciare la famiglia indigente e a lavorare come serva, lontano da casa, in una okiya, cioè una casa delle geishe. Ma anche Gong Li, che nel ruolo di Hatsumomo esterna in modo perverso e sadico le proprie frustrazioni fino a perpetrare una spietata vendetta (tema che riemerge in atteggiamenti più trattenuti ma non meno funesti ne La città proibita) finisce per ritrovarsi in una posizione ambigua e poco convincente. 4C’è da chiedersi che cosa l’abbia spinta a tanto, dopo esperienze di ottimo livello artistico e culturale, dal momento che Marshall gira una pellicola melodrammatica e un po’ fiabesca, con una scenografia in gran parte ricostruita nei pressi di Los Angeles (per esempio il quartiere Gion di Kyoto negli anni Venti e Trenta) e un happy end che forse allevia l’ansia dello spettatore di fronte al travagliato destino di Chiyo, divenuta una vera geisha col nome di Sayuri (cioè piccolo giglio), ma tradisce ogni possibile aspettativa di riscatto artistico del film. Certo il desiderio della protagonista di vivere e realizzare un amore impossibile sullo sfondo di una tradizione che esige cieca obbedienza e regole severe, può ricordare lontanamente il tema di Lanterne rosse. Ma, a ben vedere, la sostanza del film ruota intorno alla costruzione del mito dell’autenticità, però con ingredienti fasulli, come i volti cinesi prestati alle geishe. Nel caso poi di Gong Li, o meglio della semantica del suo viso con una connotazione filmica e culturale a livello internazionale, l’operazione di straniamento, vale a dire, il tentativo di vedere con occhi nuovi realtà consuete e assodate, pur concedendo tutte le attenuanti legate ai concetti di ruolo e finzione, rischia di assumere tratti un po’ grotteschi. Il mito della geisha e il significato dell’icona Gong Li nel cinema cinese sono, in altri termini, inconciliabili e solo la miopia e la leggerezza di Hollywood con il suo star-system poteva sottovalutare tali aspetti, forse ritenendo, come qualcuno ha detto, che gli occhi a mandorla sono tutti uguali.
Si potrebbe obiettare che Marshall non ha certo costretto Gong Li ad assumersi quel ruolo e che comunque le doti di una tale attrice, maturata fra i sommi maestri della “nouvelle vague” cinese, sono pressoché inesauribili e che forse una certa contaminazione di generi non nuoce, tanto è vero che intrighi, violenze e improbabili plot di thriller o film d’azione caratterizzano le sue per ora relativamente brevi esperienze americane. Tuttavia non si deve dimenticare come negli ultimi decenni cinema asiatico e americano si siano notevolmente avvicinati; un ottimo esempio resta pur sempre Chan is missing di Wayne Wang all’inizio degli anni Ottanta coronato da un buon successo di pubblico. Nella fabbrica dei sogni di Hollywood sono poi arrivati via via registi, attori, produttori e operatori con un preciso background orientale, mentre impulsi creativi sopraggiungevano da Taiwan e da Hong Kong oltreché dal Giappone e dalla Corea. C’erano motivi sufficienti per pensare ad atteggiamenti filologicamente e storicamente più corretti e a una maggiore sensibilità culturale e critica. Insomma ci sarebbero tutti gli ingredienti per utilizzare non in modo deforme e straniato fino al grottesco volti e doti di attrici radicate anche mediaticamente in un preciso humus e in una tradizione ricchissima di sollecitazioni artistiche. Questo non esclude, s’intende, l’interesse per forme più ibride, ma elaborate sul filo di un’intelligente ricerca tematica e iconografica, come suggeriscono non di rado registi quali Ang Lee e John Woo che si muovono fra diverse cinematografie.
Tuttavia il cinema americano è zeppo di strane anomalie e l’equiparazione fra giapponesi e cinesi non è certo fra le più clamorose. Spesso in ruoli di orientali furono utilizzati gli stessi europei. Basti pensare al grande attore tedesco Peter Lorre, dall’aspetto vagamente mongolo (indimenticabile la sua figura di piccolo borghese infantile in M)5, che fu il detectiv nipponico Mr. Moto o lo svedese Warner Oland che interpretò il capo dei ribelli cinesi Hen-ry Chang nel film di Von Sternberg Shanghai Express per poi vestire i panni, a partire dal 1931, dell’ispettore cinese in forza alla polizia di Honolulu, Charlie Chan, nella nota serie cinematografica. Perfino una ex attrice del regista austriaco Max Reinhardt, Luise Reiner, apparve sullo schermo come la contadina affamata O-Lang Lung nel film La buona terra (1937) di Sidney A. Franklin tratto dal romanzo di Pearl S. Buck, e fu talmente convincente da guadagnarsi l’Oscar. Né si può dimenticare che Yen, il protagonista del film di Frank Capra, L’amaro tè del generale Yen (1933) è interpretato, nella Shanghai degli anni Venti, dal danese Nils Aster; ruolo reso ancora più arduo e discutibile dal fatto che al regista stava a cuore il tema dell’attrazione-repulsione fra un’americana orgogliosa e puritana e un altero e attraente ufficiale cinese6.
Insomma a Hollywood, come si vede, anche in tempi di non smaccato ibridismo, mancava comunque ogni forma di “political correctness” nei confronti degli asiatici. Anzi in un’opera assai diffusa di Penny Delamar, The complete Make-up Artist, indirizzata ai truccatori americani, si spiega e insegna diffusamente come trasformare occidentali bianchi in “orientali”: un buon esempio in tal senso potrebbe essere Mickey Rooney nel ruolo di vici-no di casa giapponese di Audrey Hepburn nel film Colazione da Tiffany.
Nel caso di Gong Li il dibattito è invece tutto interno al mondo orientale anche se poi rimbalza nel 2007 con il film horror diretto da Peter Webber, Hannibal Lecter- Le origini del male, in un contesto europeo dove il regista ricostruisce con colpi di scena e sequenze orripilanti il romanzo di formazione di uno psicopatico affetto da cannibalismo con il quinto episodio di un’epopea di quello che è certamente l’antropofago più famoso della storia del cinema7. Che cosa abbia a che fare Gong Li con tutto ciò è presto detto: quasi nulla. Per di più, nel ruolo di Lady Murasaki, l’attrice riacquista un’identità giapponese: ha perso i parenti nell’eccidio di Hiroshima; poi, approdata in Francia, ha sposato lo zio del protagonista, il giovane Hannibal, stavolta interpretato, non senza talento, dal giovane francese Gaspard Ulliel. Gong Li, pur bravissima, sembra un corpo estraneo, trapiantata per errore in una storia dove la sua figura e il suo mondo fra preziosi ed estetizzanti kimono e cupe maschere del teatro Nō sono del tutto inconciliabili con la ricerca sulla origini del male.8 Certo Lady Murasaki, che vive dapprima in una splendida e grande casa fuori Parigi, vedova inconsolabile, fanatica del culto dei Samurai, trova ben presto uno scopo nella propria esistenza: il nipote Hannibal con un’infanzia di atrocità e dolori inenarrabili alle spalle. Ne diventa l’istruttrice, l’amica, l’amante, ma al tempo stesso l’esotica e manierata testimone di una discesa inarrestabile nell’abisso del Male. Ce n’è abbastanza per parlare, anche nel caso del regista Peter Webber di una metamorfosi radicale dopo la raffinata esperienza di un film come La ragazza dell’orecchino di perla (2003) costruito, grazie all’intensa presenza dell’attrice Scarlett Johansson, su silenzi e sguardi, lungo l’esile confine che separa arte e vita, passione e ossessione. Sconfinato nelle lande dell’abiezione e dell’orrore surreale, l’americano Webber riesce a distillare dalla bellissima Gong Li una sorta di fascino perverso, di misteriosa aura purtroppo inquinata non solo da un plot alla costante ricerca dell’effetto, ma da stereotipi che minano le stesse potenzialità dell’attrice. Può darsi che ciò che più interessava il regista, come ha detto egli stesso, fosse realizzare qualcosa di psicologicamente complesso, un viaggio nella storia e personalità di uno psicopatico per indagare le ragioni del suo cannibalismo, del suo essere un mostro. Ma poco o nulla di tutto ciò ha a che fare con Lady Murasaki, la seducente zia che insegna al nipote le arti marziali, lo coinvolge in un’intimità fatta di misticismo zen preparandolo a strani rituali di meditazione e di violenza, munita com’è, nella sua casa-santuario di un armamentario piuttosto insolito: spade, bastoni, corazze, e la maschera che il giovane Hannibal adotta nella sua vendetta, a caccia degli assassini, mercenari al servizio dei nazisti, che durante la guerra trucidarono e divorarono la sorellina. Hannibal brama solo vendetta che contagia la stessa Lady disposta ad aiutarlo ma non al punto da seguirlo sulla strada dell’aberrazione e del male assoluto. “Fermati!” è l’imperativo che nel finale ella invano gli rivolge. Hannibal nella sua sanguinaria follia è vittima di una metamorfosi senza ritorno e la zia, che gli rivolge un ultimo, vacuo interrogativo: “Quale parte di te può ancora amare?”, ne è tragicamente consapevole.
Gong Li resta una figura marginale e sacrificata nel film di Webber, ma forse il gioco stesso delle trasformazioni, il sottile spartiacque fra bene e male in situazioni estreme, il lento e progressivo maturare della vendetta sono esperienze che l’attrice porta con sé anche in performance parallele e posteriori. Negli stessi mesi in cui riflette, discute e ragiona col regista sulla sceneggiatura, l’attrice cinese gira con Michael Mann il thriller Miami Vice basato su una famosa serie televisiva degli anni Ottanta. Film d’azione sul narcotraffico, il crimine internazionale e il lato oscuro e minaccioso della globalizzazione: non è certo il set ideale per Gong Li che qui interpreta la parte di Isabella, l’affascinante amante di origine cubano-cinese del boss della droga Arcángel de Jesús Montoya che s’innamora di un detective. Quasi sempre struccata, l’attrice cinese ha un suo insolito fascino, ma diventa inevitabilmente un feticcio permutabile svuotato ormai di quella complessità umana e ideale che aveva fatto la sua fortuna e ne aveva sanzionato la sostanza artistica e culturale. Hollywood non rispetta né identità né misura e il talento di Gong Li viene abilmente riciclato ad uso e consumo di un pubblico assai meno esigente. In tutto ciò l’attrice svela comunque incredibili potenzialità. Del resto lo stesso Webber le ha riconosciuto una straordinaria capacità di adattamento e trasformazione, un’intelligenza in grado di sconfinare ben oltre il ruolo suggerito dalla sceneggiatura tanto da aggiungere sfumature enigmatiche e complesse al carattere di Lady Murasaki molto meno elaborato nel romanzo.
Certo il salto da Lady Murasaki al ruolo dell’imperatrice da lei magistralmente interpretata nel film di Zhang Yimou La città proibita, è stato enorme, ma esso non fa che confermare la giustezza delle osservazioni di Webber. Gong Li nel 2007 torna, per così dire, a casa: riprende la collaborazione con il regista amato, che nel frattempo ha abbandonato le atmosfere da dramma intimista sull’esempio di Lanterne rosse. Forse Hollywood non è passato invano, perché anche Zhang Yimou con questa sua superba e stilizzata prova registica, terzo colossal della trilogia aperta con Hero e La foresta dei pugnali volanti, mostra di non sdegnare il film d’azione e svela, oltre alla già ben nota anima realista, la vocazione per scene di massa, il ridondante gesto epico e uno straordinario gusto dei colori (si pensi al giallo dei crisantemi con una forte carica simbolica) che lascia trasparire infinite sfumature psicologiche, sentimenti ondeggianti fra odio e passione, amore e vendetta. Ben più de La città proibita, gli altri due momenti della trilogia rientrano di forza nel genere “wuxia”, del film in cui spesso è l’uso delle arti marziali a dominare e velocizzare la scena.9 Quest’ultima pellicola invece, in cui si consuma la decadenza della dinastia Tang del sec. X, riduce al minimo i duelli (ma quello fra l’imperatore e uno dei tre figli è un vero exploit artistico), e si concentra sull’intrigo con un lento e drammatico srotolarsi dei nodi irrisolti e delle contraddizioni del passato in un presente apparentemente statico, che richiama una rigida struttura teatrale e metaforica, fino all’apocalissi finale. Anche gli intermezzi quando i servitori annunciano lo scoccare dell’ora correndo velocemente per i corridoi rientrano in una gestualità da palcoscenico scandendo i vari momenti della vicenda e quasi commentandone come un coro, con la loro ritualità, l’inevitabile e cruento epilogo.
In un contesto di questo genere, dove mistero e tensione drammatica si concentrano fin dall’inizio sul rapporto fra imperatore e imperatrice (lei è la consorte in seconde nozze) il talento di Gong Li plasmato ancora una volta con grande maestria dal suo vecchio Pigmalione, ricompone un’immagine che il cinema americano aveva totalmente dissolto e ridesta, pur nel tormento e nella passionalità vendicativa e offesa, un’aura e una fasci-nazione che nascono dai silenzi, dal gioco e dalle sfumature del volto, dal trattenuto ma esplicito linguaggio degli sguardi. L’attenzione estetizzante del regista a singoli dettagli, la cura di intérieurs raffinati, l’amore verso una tradizione che si ridesta anche nella ricchezza e sontuosità dei costumi e degli arredi, sembra trasferire il singolo fotogramma o la sequenza nella dimensione del ritratto fino a dilatarsi in preziosi affreschi. Al centro palpita l’immagine dell’imperatrice che il consorte, a conoscenza della sua relazione con il figliastro, fa lentamente avvelenare con una bevanda, detta il “rimedio”, che lei crede, almeno in un primo momento, curativa. Il suo volto non tarda, di fronte alla verità, ad esprimere un furore controllato e il suo fascino regale mostra a più riprese un tormento che nel drammatico incontro con il figliastro-amante dissolve ogni compostezza in una sorta di maschera, con i capelli sciolti e il volto disfatto. La densità simbolica della sua figura, l’aura di quel volto-icona s’incrinano e svaniscono di fronte all’incalzare della tragedia che insiste sulla tormentata dialettica fra potere e follia, in cui il padre-imperatore (interpretato dal grande attore Chow Yun-Fat, maestro di ghigni sornioni e foga disperata) uccide i suoi stessi figli. Anche l’imperatrice però ha molti segreti da nascondere e Gong Li è perfetta nella sua dissimulazione, nel rancore verso il marito, nel segreto arrovellarsi in un’inutile vendetta.
E’ un tema che l’attrice aveva già affrontato anni prima nel grande affresco sul sanguinoso processo di unificazione della Cina ricostruito da Chen Kaige nel film L’imperatore e l’assassino (1999, una produzione franco-sino-giapponese), in cui nel ruolo di Zhao, concubina del re Ying dapprima progetta una finta congiura per offrire al re l’opportunità di invadere il regno di Yan, poi, di fronte alla sua sanguinaria sete di potere, ne pianifica la morte finendo però per innamorarsi dell’assassino che lei stessa ha ingaggiato. In bilico fra lealtà al suo signore, disgusto per la cieca violenza e passione, Gong Li sembrava qui portare sulle spalle tutto il dolore del mondo, pur lasciando spazio a momenti di felice intimità con Ying nel comune ricordo di una giovinezza dolce e serena. Era la storia di tre anime ferite sullo sfondo di una Cina suddivisa in molti regni e a forza unificata sacrificando migliaia di vite umane. Anche qui era forte il peso dell’intrigo, la mescolanza “di lusso e ferocia, di eleganza e sangue, la forza letale della menzogna e della bellezza”10 che potevano ricordare il mondo di Kurosawa. Del resto la storia di un moderno Re Lear nel suo splendido film Ran del 1985 è stata sicuramente un punto di riferimento anche per La città proibita, se si pensa soprattutto ai grandi quadri in movimento, ai vistosi colori e alle scene di battaglie fra le più grandiose mai apparse sullo schermo.
In prove diverse, anche a distanza di anni, nell’ambito della cinematografia del suo paese, Gong Li si è misurata più volte fondamentalmente con la dimensione del potere che tutto coinvolge e altera: vita e sentimenti privati, desideri e speranze, destini di singoli e di grandi masse. La sua duttilità artistica le permette di declinare segrete pulsioni e inquietudini collettive. Gong Li resta il volto inalterato di una tradizione e di una sensibilità storica e culturale. Un volto che suggerisce un’epopea e una tensione: è il paesaggio dell’anima cinese fra passato e presente, lo sguardo in cui ogni spettatore sogna il futuro del cinema orientale.
Note
1 F. Colamartino-M. Dalla Gassa, Il cinema di Zhang Yimou, op. cit: p. 59. Cfr. altresì sul linguaggio cinematografico del regista p. 33 sgg.
2 La perseveranza e la testardaggine con cui la donna persegue il suo obiettivo, così come l’epilogo infelice, ricordano sorprendentemente un famoso racconto, Michael Kohlhaas, del grande scrittore e drammaturgo tedesco del periodo romantico Heinrich von Kleist. Non ci sono però testimonianze relative alla conoscenza di tale testo da parte del regista.
3 Si tratta di Memorie di una geisha di Rob Marshall (2005), Miami Vice di Michael Mann (2006) e Hannibal Lecter- Le origini del male di Peter Webber (2007).
4 Può valere in proposito l’affermazione, riportata da Wikipedia, dell’attrice Maggie Cheung, a cui era stato offerto il ruolo, da lei rifiutato e interpretato poi da Micelle Yeoh, della geisha Mameha, che aiuta e protegge la piccola Chi-yo:”Non volevo tornare a casa e sentirmi dire che avevo tradito la mia cultura”. Non si dimentichi che agli occhi dell’opinione pubblica cinese la geisha è ancora sempre una mitica immagine femminile del nemico di un tempo e che vicende così drammatiche come l’invasione giapponese della Cina sono difficilmente cancellabili. A ciò si aggiunge anche un pesante tabù non ancora del tutto elaborato: e cioè il ricordo della prostituzione forzata durante la guerra da parte delle forze di occupazione giapponesi.
5 Cfr. le brevi ma intense pagine di S. Kracauer sul film di F. Lang (M. L’assassino è fra noi) del 1931 e il personaggio di Lorre in: S.K., Da Calidari a Hitler. Una storia psicologica del cinema tedesco, a cura di Leonardo Quaresima, Torino 2001.
6 Moltissimi sono gli esempi che si potrebbero citare. A cominciare da Boris Karloff che interpretò il maestro orientale del crimine, il dottor Fu Manchu, una sorta di Al Capone della Chinatown londinese, il cui scopo era combattere la razza bianca. Lo stesso Lorre vestì anche i panni di un mellifluo barone giapponese nel film antinazista Joe l’inaf- ferrabile (1942) di Edwin L. Marin. Dopo l’attacco di Pearl Harbour Hollywood aumentò la dose: nel ruolo di cinesi sofferenti sotto il dominio giapponese si ritrovano, ad esempio nel film La stirpe del drago (1944), Katharine Hepburn, Walter Huston e il georgiano Akim Tamiroff. I ruoli però s’invertono dopo la guerra. A quel punto il Giappone diventa il baluardo contro il pericolo del comunismo nel sudest asiatico. E’ l’epoca in cui il cinema americano lascia rifiorire il kitsch asiatico, duro a morire se, come si è visto, lo ritroviamo ancora nelle performance attuali. Nel nuovo trend si afferma a più riprese William Golden che pur da americano è di casa in ogni angolo d’Oriente, così come Jennefer Jones nel ruolo di cinesina (si pensi al film di Henry King, L’amore è una cosa meravigliosa del 1955), o Marlon Brando che, in qualità di giapponese con tanto di kimono, fa da interprete a Okinawa fra americani e connazionali (si fa per dire!) in La casa da tè alla luna di agosto (1965) di Daniel Mann. Negli anni Sessanta l’interesse per l’Asia diminuì: l’America era occupata con la guerra in Vietnam.
7 Gli altri episodi, affidati a registi diversi, sono nell’ordine: Manhunter-Framenti di un omicidio (1986), Il silenzio degli innocenti (1991), Hannibal (2001), Red Dragon (2002). I registi vanno da Michael Mann a Jonathan Demme, da Ridley Scott a Brett Ratner. Il serial killer cannibale negli ultimi tre è interpretato dall’ottimo Anthony Hopkins.
8 Cfr. in merito le osservazioni di F.S. Loiacono sulla rivista online NonSoloCinema, 2007. Il film è una specie di pot-pourri, di amalgama internazionale: protagonista francese e attrice cinese in una produzione franco-ceca-italiana-inglese da un bestseller americano che si svolge in Lituania e a Parigi!
9 Il genere wuxia, film d’azione e di “cappa e spada”, era molto in voga nella Hong Kong degli anni Settanta, carat-terizzato da eccessi tecnici ad ogni livello. Si tratta di pellicole che tentavano una sintesi fra un cinema opulento in costume e sequenze d’azione nello stile della trilogia Matrix dei fratelli Wachowski, in cui il mondo appare come un’ illusione e la realtà virtuale un incubo. In quel contesto fecero furore le coreografie kung fu del regista honkgonghese Yuen Woo-ping che divennero uno standard del cinema d’azione hollywoodiano
10 Cfr. l’articolo di Lietta Tornabuoni sul quotidiano La Stampa del 28 aprile 2000.
Di Clarissa Forte
*Clarissa Forte è docente di lingua cinese e ha conseguito un dottorato di ricerca sul cinema della Repubblica popolare. Ha partecipato all’organizzazione del Dong Film Festival e contribuisce all’organizzazione di numerose rassegne di cinema asiatico a Torino e Milano.