CINA. Alla catena di fast fashion Shein turni di lavoro fino a 18 ore, un solo giorno libero al mese. Ma per fine anno potrebbe essere quotata a Wall Street
Un gruppo di persone che si aggira tra grandi stanze bianche e luminose, efficienti robot impegnati a smistare pacchi di vestiti e stoffe colorate disposte armoniosamente su ampi tavoli. «Siamo nel magazzino da dove partono i prodotti che raggiungono direttamente le vostre case», spiega la lifestyle influencer Desten alle telecamere. «Ho visto con i miei occhi l’intero processo produttivo, dal design alla fabbricazione», aggiunge Dani Carbonari, modella plus-size e “confident activist”: «Una esperienza che mi ha davvero cambiato la vita».
Il video, ad oggi scomparso dai canali ufficiali, racconta il recente viaggio compiuto da sei influencer negli stabilimenti di Shein, marchio cinese di fast fashion che in pochi anni è riuscito a sfidare il monopolio dei brand occidentali. La visita sponsorizzata ha trascinato la delegazione dei personaggi influenti direttamente nell’area del Delta del Fiume delle Perle, l’hub economico e tecnologico che include metropoli come Shenzhen e Hong Kong. È qui che la Repubblica popolare ha messo a punto per decenni un modello manifatturiero ad alta intensità orientato alle esportazioni, dando origine alla rappresentazione di alienazione del capitale per eccellenza: la fabbrica cinese, con le sue file infinite di operai a basso costo che hanno permesso lo sviluppo più o meno lineare della globalizzazione.
L’ascesa di Shein ha beneficiato al massimo di questi fattori. Il sito, registrato nel 2011 grazie agli sforzi dell’imprenditore Xu Yangtian, si propone nei primi mesi come “azienda leader degli abiti da sposa”, per poi puntare a replicare i capi comparsi nelle ultime collezioni di moda. Il marchio può contare sul facile accesso alle catene di approvvigionamento globali, vista la presenza fisica in Cina e la possibilità di gestire la logistica senza bisogno di intermediari. All’infinita serie di fornitori esterni, invece, viene commissionato anche il lavoro di design dei capi. Il sapiente utilizzo degli algoritmi per captare le nuove tendenze, la comunicazione inclusiva e l’assenza di negozi fisici (quelli temporanei sono iniziati a emergere solo in un secondo momento; il primo pop-up Shein italiano è stato aperto a giugno del 2022 a Milano) hanno fatto il resto per abbattere i costi e riuscire a garantire una offerta sterminata di capi di tendenza a prezzi stracciati.
Ma se ad oggi anche le multinazionali cinesi delocalizzano in paesi come il Vietnam, dove la manodopera ha prezzi più competitivi e il mercato risente meno delle tensioni commerciali tra Washington e Pechino, le grandi metropoli della Repubblica popolare si sono ripulite per ospitare magazzini di ultima generazione e “centri per l’innovazione”, come quello mostrato nel video di Shein.
Il viaggio sponsorizzato è stato salutato sulle varie piattaforme social da una reazione furiosa, tra chi ha criticato la modalità scelta dal brand per ripulire la propria immagine e chi ha puntato il dito contro la mancanza di pensiero critico degli influencer, che hanno promosso attivamente un marchio senza porsi questioni di carattere etico. In breve tempo sono state recuperate tutte le inchieste che hanno fatto luce sulle pratiche che garantiscono una collisione surreale di abbondanza di vestiti e costi minimi.
Un primo rapporto della organizzazione svizzera Public Eye nel 2021 ha raccontato di turni di dodici ore e un solo giorno libero al mese per centinaia di dipendenti. Altre ong hanno evidenziato come fosse impossibile valutare l’impronta ambientale della società vista l’esigua quantità di dati rivelati sulla produzione. Nei mesi successivi l’azienda ha operato un controllo sui proprio contractor, da cui è emerso che il 12% aveva commesso «violazioni a tolleranza zero» (come il lavoro minorile, per intenderci) e l’83% operava con «grandi rischi». Poi la video-inchiesta dello scorso anno a cura della reporter Iman Amrani: dipendenti che lavorano anche diciotto ore di fila e pressati da altissimi target di produzione (fino a cinquecento capi al giorno al prezzo di 40 centesimi l’uno).
Alla denuncia collettiva è seguito il coro di giustificazioni, prima, e scuse, poi. La modella plus-size Dani Carbonari ha spiegato di aver preso parte al viaggio proprio per verificare le «dicerie» in merito, che secondo lei si rifacevano a una narrazione screditante propinata negli Stati Uniti. Ai suoi quasi 500 mila follower su Instagram Dani ha spiegato l’importanza di «essere indipendente e vedere le cose con i propri occhi». Poi, il 28 giugno, l’influencer ha sostituito il video con un altro in cui ammette di aver commesso degli errori. Ha aggiunto di aver partecipato a un meeting off the record con i manager dell’azienda, di aver rivolto ai presenti «un milione di domande» e di aver ricevuto risposte «autentiche»: tra le altre, che il marchio terminerebbe nell’immediato la collaborazione con i fornitori che non rispettano le leggi sul lavoro.
Nello stesso giorno la fashion designer Kenya Freeman ha chiarito che non le sembrava che gli operai e le operaie negli stabilimenti «stessero morendo di fame». In un secondo video di scuse Dani ha abbassato il tono: ha ammesso che nel mondo della moda non c’è molto spazio per le persone grasse e che aver trovato un marchio attento a questi temi le era sembrato incredibile. Come anche i prezzi stracciati, che riteneva un elemento essenziale per garantire l’accesso al mondo della moda per milioni di persone che riscontrano difficoltà perfino ad acquistare buona parte dei vestiti delle catene di fast fashion.
La polemica, oltre a esporre i limiti nella comunicazione degli influencer sui social media e i risvolti oscuri dell’industria dell’abbigliamento, potrebbe minare gli intenti di Shein di quotarsi nella borsa statunitense. Come insegna il caso TikTok, le tensioni tra le due prime economie mondiali si traducono anche nei tentativi da parte di Washington di ostacolare le grandi piattaforme cinesi che si sono fatte strada nel mercato occidentale. Nel caso della piattaforma di video brevi, alcune forze politiche Usa si sono dette preoccupate per i legami con il Partito comunista cinese e per la sicurezza dei dati degli utenti americani. Con Shein, basta la sua pessima reputazione per le condizioni lavorative e i danni ambientali.
Dopo tre anni di venti contrari, la società potrebbe riuscire a quotarsi a New York entro la fine dell’anno. A marzo è stata valutata oltre 60 miliardi di dollari in un round di raccolta fondi che ha coinvolto giganti come Sequoia Capital China e General Atlantic. Se avvenisse, il debutto potrebbe significare la maggior quotazione nella borsa statunitense di un’azienda cinese. Nel 2021 la valutazione del gigante del ride-hailing Didi era ammontata a 68 milioni di dollari, ma il giro di vite di Pechino sui colossi tech del paese aveva comportato la cancellazione dal listino Usa. Per ora dal Partito comunista non sono emersi elementi che potrebbero far pensare a prese di posizione nei confronti di Shein: all’azienda non resta altro che superare l’ennesimo scandalo internazionale.
Pubblicato su Il Manifesto
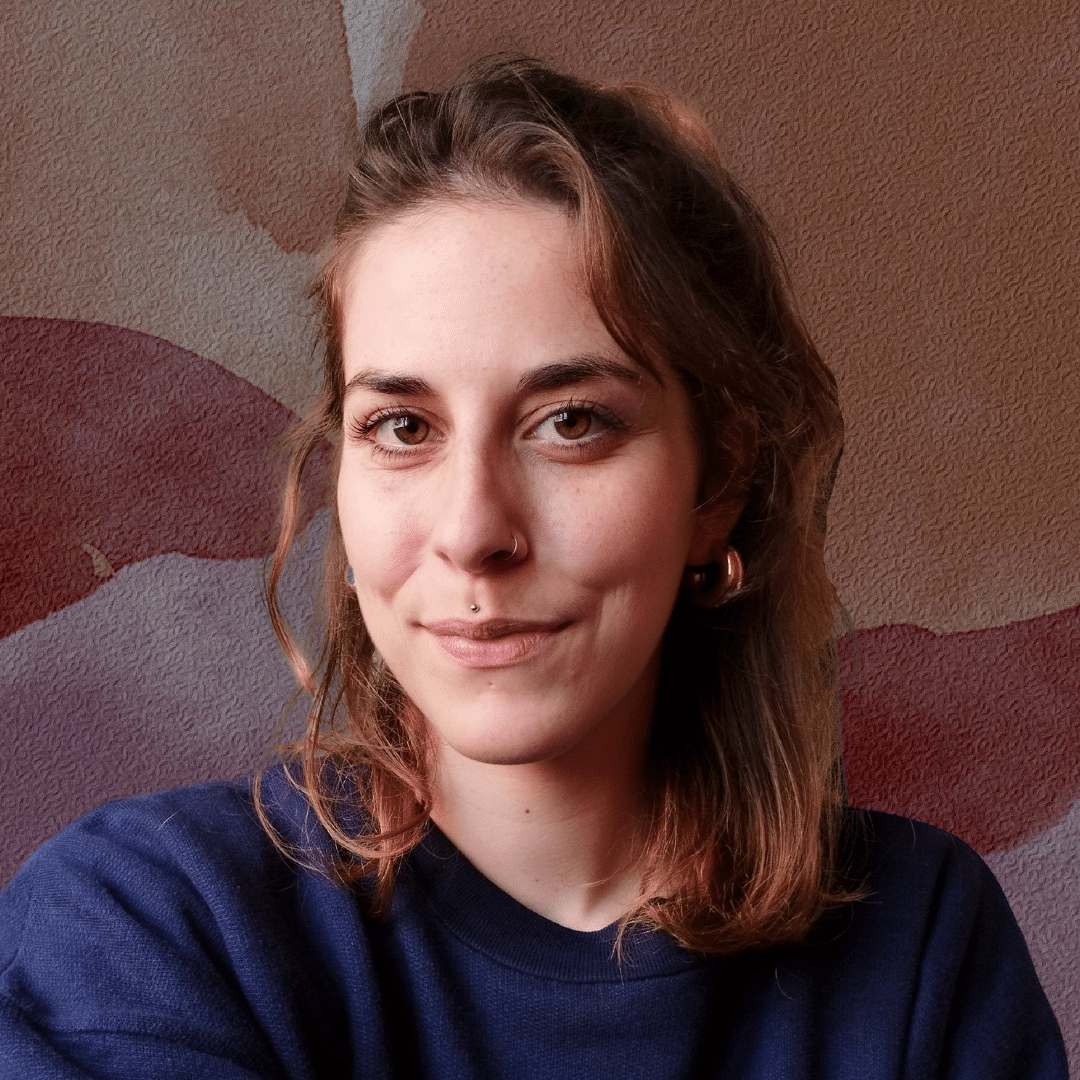
Marchigiana, si è laureata con lode a “l’Orientale” di Napoli con una tesi di storia contemporanea sul caso Jasic. Ha collaborato con Il Manifesto, Valigia Blu e altre testate occupandosi di gig economy, mobilitazione dal basso e attivismo politico. Per China Files cura la rubrica “Gig-ology”, che racconta della precarizzazione del lavoro nel contesto asiatico.


