Da prodotto culturale per mobilitare le masse, nel corso dei decenni i poster di propaganda sono finiti per essere oggetti di collezione, se non quando gadget per turisti curiosi. “Dialoghi” è una rubrica in collaborazione tra China Files e l’Istituto Confucio di Milano
Ad oggi non è raro che tra le bancarelle di antiquariato o dei semplici mercati cittadini, in Cina, ci si imbatta in vecchi poster di propaganda o perfino gadget su cui troneggia il volto di Mao Zedong: ora articoli da collezione e gadget per turisti curiosi, un tempo prodotti di poco valore e diffusi ovunque per un preciso scopo di mobilitazione delle masse.
L’utilizzo di opere letterarie, illustrazioni, canzoni e spettacoli teatrali da parte del sistema politico cinese al fine di diffondere codici comportamentali e canoni di pensiero corretti è pratica comune. Ma l’arte e la propaganda diventano un tutt’uno ancor prima della fondazione della Repubblica popolare cinese: nei noti Discorsi sull’arte e la letteratura a Yan’an nel 1942, il leader chiarisce come le produzioni culturali debbano esistere solo al servizio della rivoluzione, indirizzare alle masse e avere come argomento le masse.
Una delle forme più conosciute di manifesti che fungono da veicolo di messaggi politici è quella dei dazibao (dàzìbào, 大字报), i “manifesti a grandi caratteri” utilizzati già dai tempi dinastici ma divenuti più comuni con l’incremento della alfabetizzazione. Un saggio di Denise Y. Ho dell’Università di Yale, pubblicato nell’ambito del progetto The Mao era in objects del King’s College di Londra, chiarisce che se spesso vengono “visti come una forma di protesta dal basso verso l’alto”, quindi nella forma di critica verso le istituzioni, a volte “le storie orali e le memorie rivelano che il processo di scrittura è stato più complicato, a volte dall’alto verso il basso e altre volte in modo collettivo”.

|
La loro diffusione raggiunge livelli record durante il decennio di Rivoluzione culturale, ma Mao ne incoraggia l’uso ben prima, come si evince da queste sue parole del 1958: “Un manifesto a grandi caratteri è una nuova arma estremamente utile. Può essere usato ovunque, purché ci siano le masse. È stato ampiamente utilizzato e dovrebbe esserlo all’infinito”. Quello scritto di suo pugno diventa lo slogan più noto dell’epoca: al grido di “bombardare il quartier generale” (pào dǎ sīlìng bù, 炮打司令部) il “Grande Timoniere” sguinzaglia una intera generazione contro il Partito stesso, dando via ai tumulti della Rivoluzione culturale e alle scorribande delle Guardie Rosse.

“Bombardare il quartier generale”, 1966, chineseposters.net |
Ma se per comprendere questo genere di prodotti artistici serve saper leggere e padroneggiare la lingua, i manifesti illustrati possono essere fruibili da tutti. Nel periodo maoista i poster di propaganda fanno capolino in ogni aspetto della vita quotidiana e lavorativa: ne esistono di adatti per le scuole, riempiono le pareti di uffici e fabbriche, si trovano per pochi spicci in ogni libreria Nuova Cina. Si fanno portatori di tutte le campagne dell’epoca e diventano un mezzo di comunicazione ideale per scopi educativi perché capaci di raggiungere il gran numero di analfabeti.

Baba, zheige zi shi zheiyang xiede, 爸爸, 这个字是这样写的: “Papà, è così che si scrive questo carattere”. Manifesto per promuovere l’alfabetizzazione del 1954, con uno stile che ricorda i manifesti di calendario degli anni Venti, chineseposters.net |
I protagonisti sono per la maggior parte membri della classe operaia o contadini. In netto contrasto con un certo tipo di estetica delle yuèfènpái 月份牌, i personaggi femminili ritratti nei calendari ante-guerra, le donne dei poster di propaganda vengono “mascolinizzate” per eliminare quasi del tutto le differenze di genere.
Dal 1965 il Partito comunista intraprende una campagna che punta a promuovere Mao come leader rivoluzionario ben oltre fuori i confini nazionali. Il volto del “Grande Timoniere” finisce per adornare anche oggetti di vita quotidiana come segnalibri, scatole di biscotti, specchi, pacchetti di sigarette o scatole di fiammiferi. Gli artisti che sono chiamati a raffigurarlo devono rispettare delle precise condizioni: deve essere “dipinto di rosso, luminoso e spendente” (hóng 红, guāng光, liàng亮)

Didascalia: “La luce del pensiero di Mao Zedong illumina la strada della Grande Rivoluzione Culturale Proletaria” (Mao Zedong sixiang de yangguang zhaoliangwuchan jieji wenhua da geming de daolu, 毛泽东思想胡阳光照亮无产阶级文化大革命的道路). 1966, chineseposters.net |
Visti gli sforzi di promozione oltre i confini nazionali, i poster di propaganda attraggono l’interesse degli occidentali fin dal 1949. Ne parla in un saggio uscito su Harvard International Review Stefan R. Landsberger, professore emerito all’Università di Amsterdam. Nei suoi lunghi anni di vita e viaggio in Cina lo studioso ha messo mano su una enorme quantità di manifesti, che sono finiti in una collezione progettata assieme all’Istituto Internazionale di Storia Sociale di Amsterdam: conta oltre 10 mila pezzi ed è accessibile gratuitamente al sito chineseposters.net.
Landsberger spiega che alcuni sono attratti da questi articoli popolari perché simpatizzano con il regime maoista, altri perché con un approccio orientalista sono attratti da oggetti considerati alieni, sovversivi e misteriosi. Fino agli anni Settanta è necessario andare nella Repubblica popolare per mettere mano su una di queste stampe di propaganda: i manifesti “servivano come una sorta di souvenir della Cina rivoluzionaria, a differenza dell’artigianato più tradizionale (sete, paraventi di seta, rotoli di calligrafia, sculture, ecc.)”.
I cittadini cinesi che ne sono interessati e che vogliono collezionarli, invece, incontrano non pochi ostacoli. L’idea stessa di collezionare qualcosa rientra nell’attività di hobby e quindi è espressione della borghesia. Inoltre, il fatto che sono praticamente ovunque e facilmente accessibili non li rende un prodotto di valore.
Con la morte di Mao e l’avvento delle riforme si dà il via libera alle velleità di curiosi e appassionati. Molti si interessano anche a recuperare ciò che è rimasto delle illustrazioni pubblicitarie degli anni Venti e Trenta in stile Art Déco. I manifesti di propaganda, nel frattempo, iniziano a diminuire: “meno campagne, meno enfasi sui culti della personalità, nuove forme di arte e intrattenimento che entrano nelle case”, come si legge in un articolo di The China Project dedicato a Landsberger.
In quel periodo il Partito tenta di affievolire il culto del “Grande Timoniere”, ma è impossibile eliminarlo dalla memoria collettiva. Ciò che si può fare è far finire nel dimenticatoio le tragedie che si sono registrate durante il periodo maoista, e trasformare Mao in una figura da ricordare con affetto quasi nostalgico, come “nonno Mao”.
Già negli anni Novanta i cinesi iniziano a farne esperienza in un modo nuovo. Come racconta Camilla Fatticcioni in una puntata della rubrica Chinoiserie, in quel periodo alcuni artisti danno una nuova interpretazione al codice estetico dei poster maoisti: si fa largo una produzione artistica che prende il nome di “pop politico”, le cui opere accostano “le immagini di propaganda della Rivoluzione culturale con i simboli della globalizzazione e del capitalismo”.
Ad oggi i manifesti di propaganda sono rilegati nei mercati antiquari, uno tra tutto quello di Panjiayuan a Pechino. I venditori privati sono emersi come la fonte più preziosa per interessati e collezionisti. L’aumento della domanda, si legge nel saggio su Harvard International Review, ha fatto lievitare i prezzi. Se negli anni Ottanta i manifesti costavano non più di due mao (meno di tre centesimo di euro), ad oggi alcuni hanno raggiunto o superato i 2000 yuan. Con le nuove tecnologie è diventato sempre più difficile riconoscere un poster originale dell’epoca da una ristampa recente.
L’arte di propaganda rappresenta una parte importante della eredità storica cinese. Mao è ancora oggi una presenza diffusa nelle case degli abitanti delle aree rurali ed è diventato un elemento funzionale agli intenti nazionalisti, ad esempio nelle manifestazioni sportive. La sua figura resta popolare e intrigante per le nuove generazioni, tanto da venire elevata a vessillo ideologico in alcune mobilitazioni collettive che si sono registrate nel paese negli ultimi anni.
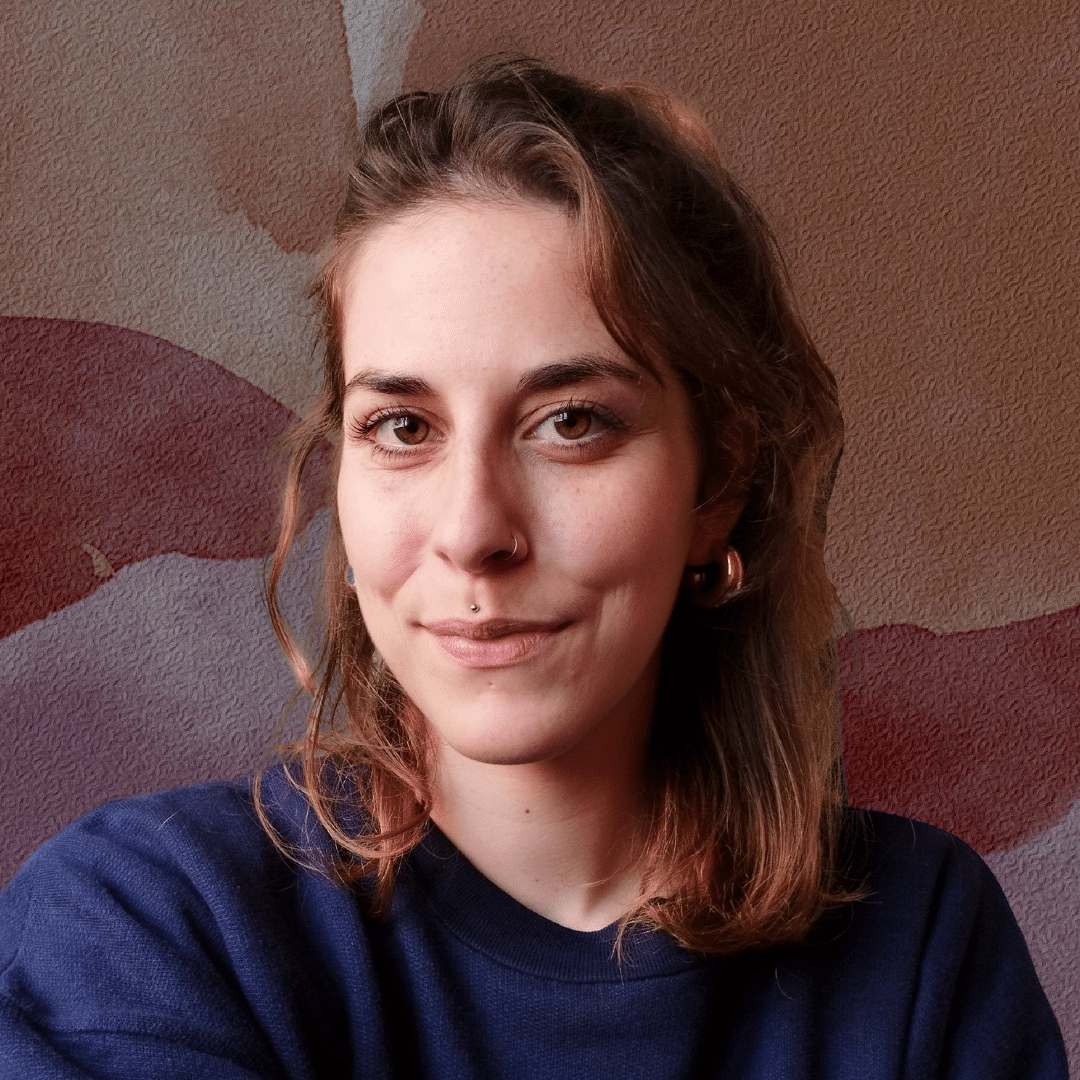
Marchigiana, si è laureata con lode a “l’Orientale” di Napoli con una tesi di storia contemporanea sul caso Jasic. Ha collaborato con Il Manifesto, Valigia Blu e altre testate occupandosi di gig economy, mobilitazione dal basso e attivismo politico. Per China Files cura la rubrica “Gig-ology”, che racconta della precarizzazione del lavoro nel contesto asiatico.

