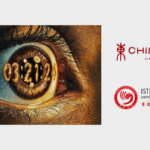In quasi cinque decenni di attività, Zhang Yimou ha fatto conoscere a livello internazionale generi tipicamente cinesi come il wuxia, conquistando premi e successi al botteghino con una commistione di storie coinvolgenti e drammatiche ed elementi folkloristici. “Dialoghi: Confucio e China Files” è una rubrica in collaborazione tra China Files e l’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano
Dopo la premiazione del regista e sceneggiatore giapponese Kitano Takeshi nel 2022 e di Baisho Chieko, uno dei volti più popolari del cinema nipponico, l’anno successivo, quest’anno tocca alla Cina. Il 2 maggio, sul palco del Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”, la ventiseiesima edizione del Far East Film Festival assegnerà alla leggenda del cinema cinese Zhang Yimou il Gelso d’Oro alla Carriera. Un premio che «rappresenta qualcosa che va oltre le motivazioni più evidenti: è il nostro modo per dirgli “Grazie, maestro” e per restituirgli, simbolicamente, tutto quello che ci ha dato», come si legge nel comunicati stampa nelle parole di Sabrina Baracetti e Thomas Bertacche, responsabili del FEFF.
In quasi cinquant’anni di attività, il regista ha diretto oltre venti film capaci di emozionare i cittadini della Repubblica popolare e ottenere un ampio consenso internazionale. Una carriera puntellata di premi (festival di Cannes, Berlino e Venezia) e di nomination agli Oscar (tre), caratterizzata dal coinvolgimento in eventi fondamentali per la reputazione di Pechino (gli viene affidata la direzione artistica delle cerimonia di apertura alla XXVIII edizione dei Giochi Olimpici di Pechino 2008) ma anche da episodi di censura per aver veicolato attraverso i suoi film critiche poco velate al paese.
È il caso di One Second, del 2019, i cui riferimenti agli anni tumultuosi della Rivoluzione culturale obbligano il regista a ritirare il film dal concorso della Berlinale per presunte “difficoltà tecniche”. Malgrado i pesanti tagli con cui ricompare due anni dopo, il film riesce ancora a comunicare quel senso nostalgico che lo accosta alle prime opere di Zhang, non ancora interessate dalle dinamiche spettacolari dei blockbuster. In un piccolo avamposto nel deserto del Gobi, vari personaggi si impegnano nel recuperare una bobina cinematografica, ognuno per un motivo differente: l’intenzione ultima è evidenziare il ruolo che il cinema ha sempre ricoperto in Cina, come forma d’arte che dialoga con la comunità e ne rappresenta i bisogni. Una visione che si discosta dalla produzione hollywoodiana, che, come scrive William Schwartz su The China Project, ha sempre cercato “di creare dei fandom che accettassero acriticamente i loro messaggi di marketing”. Zhang Yimou non è stato però estraneo a questa tendenza: The Great Wall del 2016 è l’esito bizzarro (e fallimentare al botteghino) dei tentativi della produzione statunitense di assecondare il mercato cinese.
A parte le scivolate contenute, Zhang è il maestro per eccellenza, colui che ha portato il cinema cinese nel mondo. Esponente di spicco dei registi della cosiddetta “quinta generazione”, quella che ha permesso al cinema della Repubblica popolare di affermarsi sulla scena internazionale, come molti suoi coetanei ha vissuto sulla propria pelle le difficoltà della lotta politica. La sua è una storia di coraggio e di episodi al limite del mito, come quello che lo vede tornare dal periodo di esilio nei campi di lavoro durante la Rivoluzione culturale e vendere il proprio sangue per riuscire ad acquistare la sua prima cinepresa.
L’esordio con Sorgo Rosso nel 1987 dà prova della sua abilità nell’intrecciare il dramma e il folklore, e sancisce l’inizio della solida relazione con l’attrice Gong Li. Due anni dopo, la nascente star ritorna nei panni di Ju Dou, nell’omonimo film. Se Nove Fiori, la protagonista di Sorgo rosso, viene data in sposa a un vecchio uomo affetto da lebbra e proprietario di una distilleria, nel secondo film la giovane è costretta a sposare un anziono a capo di una tintoria. In entrambi i casi la narrazione dei personaggi femminili veicola coraggio e determinazione, dando prova della capacità del regista di toccare temi al tempo tabù in Cina, come la sessualità e le storture della società patriarcale.
Sostanza, oltre che stile e scene ammalianti. Dopo la nomination agli Oscar di Lanterne rosse (1991) e il Leone d’Oro a Venezia per La storia di Qiu Ju nel 1992 (che consente a Gong Li di vincere la Coppa Volpi per la miglior attrice), nei primi anni Duemila il nome di Zhang irrompe definitivamente sulla scena internazionale con due capolavori in costume di genere wuxia (武侠, i “combattimenti cavallereschi”): Hero regala un perfetto simbolismo cromatico che narra i differenti stati d’animo dei due protagonisti, il re di Qin e un prefetto anonimo a cui però il re deve la vita; la Foresta dei pugnali volanti conduce lo spettatore in mirabolanti combattimenti di epoca Tang, in una società oppressa da un governo corrotto e caratterizzata da sommosse di bande armate.
L’enorme successo commerciale fuori dall’Asia si trascina ancora ad oggi e le immagini spettacolari e ipnotiche dei due blockbuster vengono ancora elogiate in contenuti ad hoc per i social media. Ma all’epoca non sono mancate le critiche, tra colleghi registi che parlavano di una vita artistica ormai al capolinea e spettatori che hanno tacciato Zhang di aver pensato a personaggi molto superficiali, che agiscono sullo sfondo di trame illogiche. Secondo molti, l’utilizzo diffuso di elementi stereotipati della cultura cinese, come le lanterne, è funzionale alle ambizioni di riconoscimento e apprezzamento all’estero più che alla volontà di rappresentare le varie sfaccettature della società contemporanea cinese. Le produzioni successive, come La maledizione del fiore d’oro del 2006, che unisce elementi wuxia al film di guerra e ai drammi da palazzo, sembrano rispondere a una richiesta collettiva di maggior complessità.
Al regista va di certo riconosciuto la capacità di aver portato i generi e le caratteristiche principali del cinema cinese in tutto il mondo. “I nostri film devono uscire dai confini del paese”, ha dichiarato in una conferenza stampa in occasione del 13° Festival Internazionale del Cinema di Pechino: “ Solo quando avremo raggiunto questo obiettivo potremo dire che i film cinesi hanno una forte influenza e che abbiamo contribuito al miglioramento dell’umanità e del mondo”.
Intervistato in occasione dei British Academy Film Awards del 2015 sulle possibilità per le nuove generazioni di cineasti di entrare nell’industria cinese, Zhang risponde con fiducia che a differenza degli altri paesi la Cina di quel periodo si presenta come un “paradiso” per l’arte ed è capace di offrire possibilità a tutti, indipendentemente dall’esperienza. Negli anni successivi il mercato della Repubblica popolare si è anche dimostrato capace di resistere all’impatto del Covid-19, mantenendo il secondo posto a livello internazionale. Lo scorso anno gli incassi totali hanno raggiunto i 45 miliardi di yuan, segnando un aumento del 49% rispetto all’anno precedente.
Dopo i successi di Cliff Walkers e Snipers (rispettivamente del 2021 e del 2022), il 2023 ha confermato per l’ennesima volta la buona riuscita delle sue produzioni. Uscito durante le festività del Capodanno lunare, Full River Red si è rivelato un successo al botteghino incassando più di 670 milioni di dollari e attestandosi al sesto posto nei titoli della Repubblica popolare di maggior incasso di tutti i tempi. Otto mesi dopo il giallo ambientato agli albori della dinastia Song (960-1279), il regista è uscito con Under the Light, un contorto dramma criminale e il primo dopo tempo ad essere ambientato nel contesto urbano.
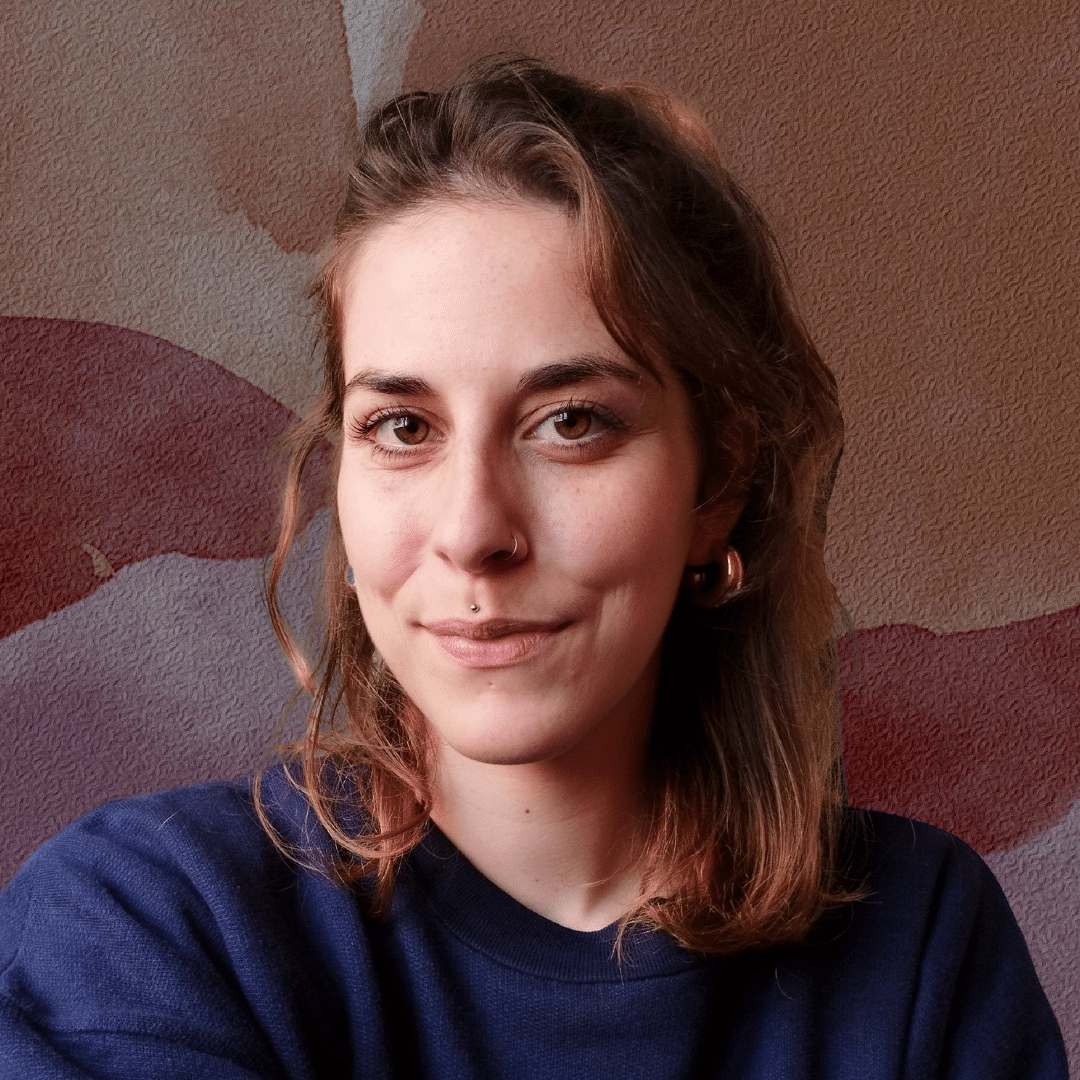
Marchigiana, si è laureata con lode a “l’Orientale” di Napoli con una tesi di storia contemporanea sul caso Jasic. Ha collaborato con Il Manifesto, Valigia Blu e altre testate occupandosi di gig economy, mobilitazione dal basso e attivismo politico. Per China Files cura la rubrica “Gig-ology”, che racconta della precarizzazione del lavoro nel contesto asiatico.