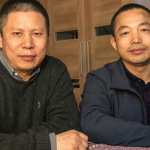All’assioma ormai consolidato secondo il quale lo sviluppo materiale, il progresso, e la crescita economica, rientrino tra i diritti umani, Pechino ha aggiunto un nuovo postulato: che lo stesso valga per “l’uguaglianza delle relazioni, attraverso l’apprendimento delle differenze culturali.”
“In un momento di gravi sfide per la governance globale, la Cina sostiene la salvaguardia dei diritti umani insieme alla sicurezza, rispettando la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i paesi”. Sicurezza, sovranità e diritti umani: non è un trittico scontato. Almeno non per noi occidentali, abituati ad associare il concetto di human rights ai cosiddetti valori universali.
All’assioma ormai consolidato secondo il quale lo sviluppo materiale, il progresso, e la crescita economica, rientrino tra i diritti umani, Pechino ha aggiunto un nuovo postulato: che lo stesso valga per “l’uguaglianza delle relazioni, attraverso l’apprendimento delle differenze culturali.”
Ma andiamo per ordine: in principio fu la Global Development Initiative (GDI), l’iniziativa lanciata dal presidente Xi Jinping nel 2021 da una parte per allineare gli obiettivi di sviluppo cinesi all’Agenda 2030 dell’Onu. Dall’altra per dare una veste più bonaria alla politica estera cinese dopo le critiche suscitate dall’insostenibilità finanziaria della Belt and Road Initiative (la Nuova via della seta). L’idea è che, come le “caratteristiche cinesi” hanno permesso alla Repubblica popolare di emancipare 800 milioni di persone dallo stato di povertà in soli quarant’anni, così ogni paese debba trovare un percorso di sviluppo cucito su misura.
Incoraggiato dall’ampia adesione alla GDI, nei seguenti due anni Xi ha annunciato altre due sigle complementari: la Global Security Initiative (GSI) e la Global Civilization Initiative (GCI). Se la prima sostiene che la difesa della sicurezza nazionale debba avvenire nel rispetto della sovranità altrui, la seconda – riallacciandosi alla GDI – sostiene sia necessario “garantire un equo accesso ai diritti umani da parte delle persone di tutti i paesi attraverso percorsi di modernizzazione con le proprie caratteristiche”.
L’occasione per formalizzare tale visione è arrivata con il Forum sulla governance globale dei diritti umani, che quest’anno ha avuto per tema l’”Uguaglianza, la Cooperazione e lo Sviluppo”. L’evento – organizzato a Pechino il 14 giugno – ha coinciso con il 30° anniversario della Dichiarazione e del Programma d’azione di Vienna, un documento dell’Onu che promuove i diritti umani. Il tempismo non è casuale. Sempre più spesso le iniziative cinesi intersecano l’agenda delle organizzazioni internazionali con l’obiettivo di acquisire legittimità agli occhi dell’occidente e soprattutto del Sud globale: soprattutto Africa, Medio Oriente, America Latina e alcune nazioni del Sud-est asiatico. È qui che il paradigma di sviluppo cinese riscuote maggiore successo facendo leva sul comune risentimento per il passato coloniale.
Come spiegato da Xi in apertura al forum, la Cina sostiene la promozione dei diritti umani con la cooperazione nello spirito del rispetto reciproco e dell’uguaglianza, e approfondendo gli scambi e l’apprendimento reciproco tra le civiltà”. Non serve troppa fantasia per capire che la GCI sia una risposta alla diplomazia su basi ideologiche promossa da Stati Uniti e alleati. Il concetto è stato elaborato dall’agenzia di stampa statale Xinhua in un recente op-ed. Letteralmente: “Oggi la governance globale dei diritti umani sta affrontando gravi sfide. Alcuni paesi occidentali, sotto la bandiera dei cosiddetti ‘diritti umani universali’ e ‘diritti umani al di sopra della sovranità’, stanno promuovendo con forza concetti e sistemi democratici occidentali in tutto il mondo per orchestrare ‘rivoluzioni colorate’.” Ecco che, secondo il governo cinese, alla retorica dei diritti umani serve un cambio di regime.
L’organo di stampa ufficiale cinese contesta soprattutto il fatto che “alcuni paesi, pensando di essere ‘stati ideali perfetti’, “vogliono sempre agire come ‘insegnanti’ per imporre ad altri paesi doppi standard e interferire negli affari interni” altrui. Al contrario – a suo dire – la Cina propone una visione ‘win-win’ dei diritti (non universali) per il ‘progresso comune’.
È una tenzone in corso da diversi anni, specialmente da quando gli Stati Uniti e alcuni parlamenti europei hanno bollato come “genocidio” le controverse politche etniche imposte da Pechino nella regione uigura dello Xinjiang. La guerra in Ucraina ha ravvivato il dibattito: la posizione cinese non implica una condanna esplicita dell’invasione russa, sebbene nei comunicati ufficiali venga auspicato con sottile ambiguità il rispetto della sovranità di tutti i paesi.
Per capire la posizione cinese basta riascoltare le parole dell’ex ambasciatore cinese a Washington. Secondo Cui Tiankai, “alcune persone vogliono che un certo paese [leggi: l’Ucraina] combatta fino alla totale distruzione, il che equivale a un genocidio”. Il commento è giunto dal palco del World Peace Forum, altro evento diplomatico promosso da Pechino a inizio mese, durante il quale i presenti hanno accusato l’Occidente di ambizioni egemoniche, egoismo, e ipocrisia per aver imposto sanzioni alla Russia senza tenere conto delle legittime preoccupazioni di Mosca nei confronti del pressing NATO. Lo stesso starebbe facendo con qualsiasi regime guidato da principi non liberali e democratici: la Cina, ma anche tutti quei paesi amici dove le iniziative politiche cinesi (sostanziate da generosi investimenti) riscuotono un consenso quasi plebiscitario.
Ecco che la Cina si erge a paladina del multilateralismo, pietra angolare del “vero” ordine mondiale. Un ordine mondiale sempre più spostato a Est e a Sud. Chi però conosce la Cina – e soprattutto il cinese – sa che in realtà il termine wenming (文明 civiltà) negli ultimi decenni ha assunto un’accezione “elitaria” se paragonato a wenhua (文化 cultura), perché implica uno stadio più elevato di sviluppo tecnologico e sociale. D’altronde, come spiega Ryan Ho Kilpatrick di China Media Project, “ogni nazione ha una cultura, ma solo poche vantano una civiltà”. Pochissime vantano una civiltà antica come quella cinese.
Il concetto è stato esposto recentemente da Liu Jianchao, capo del dipartimento internazionale del partito comunista cinese che, ribadendo la controversa datazione ufficiale, ha retrodatato l’inizio della storia cinese a 5000 anni fa. Un passato mitico non ancora supportato da prove scientifiche né da testi scritti. Ma a cui il funzionario si è ugualmente appellato per sostenere la natura intrinsecamente pacifica della Cina. Nonostante le prime forme di scrittura accertata risalgano a circa duemila anni più tardi, ammiccando al mondo emergente, Liu ha sottolineato come il carattere cinese “pace” sia scomponibile in due parti: quella a sinistra raffigurante un gambo di riso, l’altra a destra una bocca. Fin dall’antichità, oltre la Muraglia, la pace viene quindi associata alla sicurezza alimentare e allo sviluppo. Insomma, a quella sussistenza materiale che la dirigenza comunista vanta tra le proprie “specialità” e che oggi cita tra i diritti umani.
Si tratta di un’operazione “revisionista” volta a dare prestigio internazionale alla Cina ma anche a credibilità alla sua classe politica. Come osserva Nicholas Dynon, ricercatore presso la Macquarie University di Sydney, morta e sepolta la lotta di classe, il partito-stato cerca nuove fonti di legittimità. Cosa c’è di meglio che presentarsi come erede della millenaria civiltà cinese? Presentarsi come erede della millenaria civiltà cinese e promotore di un’ordine globale più “giusto ed egualitario”.
Di Alessandra Colarizi
[Pubblicato su Gariwo]
Classe ’84, romana doc. Direttrice editoriale di China Files. Nel 2010 si laurea con lode in lingua e cultura cinese presso la facoltà di Studi Orientali (La Sapienza). Appena terminati gli studi tra Roma e Pechino, comincia a muovere i primi passi nel giornalismo presso le redazioni di Agi e Xinhua. Oggi scrive di Cina e Asia per diverse testate, tra le quali Il Fatto Quotidiano, Milano Finanza e il Messaggero. Ha realizzato diversi reportage dall’Asia Centrale, dove ha effettuato ricerche sul progetto Belt and Road Initiative. È autrice di Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro.