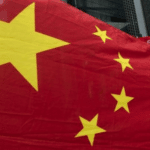Ha molto a che fare con il modello economico persistente basato sulla proprietà immobiliare, un settore che rappresenta circa il 30% del Pil. Dietro al fenomeno concorrono molteplici fattori, ma si tratta chiaramente di una dispersione di risorse che altrimenti potrebbero essere incanalate per investire nell’istruzione, nella sanità e nelle reti sociali. Dal 2009, insieme al massiccio pacchetto di stimoli varato dopo la crisi finanziaria internazionale, il settore immobiliare è stato un importantissimo fattore di crescita. Ma al contempo ha contribuito ad aggravare la speculazione finanziaria e, appunto, la disuguaglianza sociale, rendendo impossibile per molti giovani permettersi un alloggio di base. A questo punto è necessario cambiare.Questo cambiamento dovrebbe avvenire potenziando i consumi interni. L’economista Cai Fang ha recentemente affermato che il modello di crescita basato sugli investimenti non funziona più e che l’economia cinese è entrata in una “nuova nuova normalità”, causata dal costante calo della popolazione e dalla generale sfiducia post-Covid. Per stimolare la spesa interna l’esperto invita ad accelerare la riforma dell’hukou, il sistema che limita l’accesso dei cittadini ai servizi essenziali in base alla residenza d’origine. Condivide l’analisi?
L’hukou urbano, in realtà, si basa sulla dimostrazione delle capacità finanziarie e occupazionali. Infatti l’acquisto di un’unità abitativa può portare a un trattamento simile a quello dell’hukou famigliare. Come in passato, tutt’oggi l’hukou è uno strumento di controllo che permette alle grandi città di contenere la dimensione aggregata delle loro popolazioni e i costi associati al mantenimento dei servizi sociali di base. Questo spiega perché la riforma procede così lentamente.
In un articolo pubblicato sulla rivista del Pcc, Qiushi, Xi Jinping ha escluso di avvalersi dei sussidi statali per alleviare le difficoltà economiche della popolazione, mettendo in guardia dal “cadere nella trappola di allevare i pigri attraverso l’assistenzialismo”. Secondo alcuni media anglofoni, l’obiettivo della leadership cinese è allontanarsi volutamente dal modello economico occidentale e dimostrare la superiorità (o quantomeno “esclusività”) del “socialismo con caratteristiche cinesi”. Ma è davvero così?
Da una lettura forse superficiale della citazione mi sembra una risposta al cosiddetto movimento degli “sdraiati” (tangping): invece di intraprendere lavori ad alta intensità di manodopera, alcuni giovani [disoccupati e senza speranza per il futuro] oggi chiedono la loro “giusta quota” del progresso ottenuto dal paese. È difficile ragionare attraverso la dicotomia Occidente-Oriente. Alla fine, il vero problema è il divario tra le aspettative individuali e le opportunità di lavoro disponibili. Ma questo problema d’altronde esiste in tutte le società, no?
Secondo le ultime proiezioni di Bloomberg, la Cina ormai non supererà gli Stati Uniti prima del 2040. In quali settori l’economia cinese ha ancora vantaggi competitivi e in quali invece ritiene sia in svantaggio?
L’apparente ossessione per il divario tra il Pil di Cina e Stati Uniti è, per me, sbalorditiva. Finché avremo giurisdizioni diverse ci sarà sempre un’economia numero uno al mondo. Ma anche il mantenimento di uno status numerico ha un costo. Sarebbe più razionale elaborare politiche che non causino choc economici e sociali, qualunque sia la posizione nel ranking mondiale. In un certo senso possiamo dire che in Cina – ma in realtà, anche in America e altri paesi – praticamente tutti i settori si trovano ad affrontare degli svantaggi. Perché ogni settore in cui un’economia è tecnicamente più avanzata, anche se gestita in modo efficiente – a meno che non riesca davvero ad autosostenersi completamente all’interno dei propri confini – dipende in ultima istanza dal supporto di clienti dall’estero.
Negli ultimi due anni l’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud Est asiatico, è diventato il primo partner commerciale della Cina, soppiantando Stati Uniti e Ue. Le motivazioni sono politiche oppure le esigenze economiche della Cina sono cambiate?
Le catene di produzione sono in continua evoluzione. Le politiche del “de–risking” e del “decoupling” (disaccoppiamento) da parte degli Stati Uniti dal 2017, e più recentemente dell’Ue, sono in parte responsabili di questo avvicendamento. Ma esiste un precedente storico, ad esempio nel modo in cui il Giappone ha cambiato i suoi principali partner commerciali alla fine degli anni ’80 e ’90. La manodopera e altri costi operativi in Cina ormai non sono competitivi quanto quelli dei paesi dell’Asean. Questo, oltre alla geografia dei trasporti, è uno dei principali fattori trainanti del fenomeno. Per la Cina, la questione più pertinente è come evitare uno svuotamento industriale: sì, c’è una crescita complessiva dei profitti aziendali derivanti dagli investimenti al di fuori del paese, ma si tratta di una crescita senza creazione di occupazione sul fronte interno. In un certo senso, la Cina si trova ad affrontare la stessa situazione che ha portato americani ed europei a modificare le loro politiche commerciali e occupazionali nei confronti della Cina. La linea di fondo? Qualunque sia il cambiamento nella distribuzione geografica delle partnership commerciali, il gioco è dettato dalle catene di approvvigionamento mondiali, non solo dai profitti.
Secondo diversi analisti, il problema è che Pechino starebbe anteponendo la sicurezza nazionale alla crescita economica. Va detto che ormai Stati Uniti e Ue, in alcune circostanze, non sono da meno. Eppure le loro economie non sembrano risentirne quanto quella cinese. Forse la Cina sconta il freno di un sistema sempre più centralizzato?
La “sicurezza”, nel pensiero e nella politica cinese, coinvolge almeno tre dimensioni: la sicurezza militare; la sicurezza sia in senso tecnico-operativo sia in termini di gestione dell’economia, della società, e delle incertezze future; e infine l’adeguatezza a livello personale, familiare e sociale. Ad esempio anche il risparmio è una misura legata alla sicurezza. Quindi sì, i documenti in lingua cinese (principalmente destinati al consumo interno) parlano molto di “sicurezza nazionale”. Ma non sono così “fastidiosi” per il cittadino medio. L’enfasi sulla “sicurezza nazionale” non implica in alcun modo fare cose a scapito della crescita economica o dello sviluppo e della coesione sociale. Al contrario, non è necessario essere un marxista devoto per accettare la natura dialettica della prosperità economica e della sicurezza nazionale. Con questo non sto dicendo che l’interpretazione cinese dell’idea di “sicurezza nazionale” sia esclusiva, o che implichi in alcun modo una superiorità. Ma penso che sia un concetto tutt’altro che “stravagante”, a dispetto di come a volte viene invece dipinta all’estero. In fin dei conti, è il grado di successo nella gestione di circostanze in continua evoluzione che determina la qualità della retorica della “sicurezza nazionale”.
Parlando di sicurezza, l’Italia lascerà la nuova Via della Seta (Bri). A differenza di altri casi simili la risposta di Pechino è stata molto misurata. È perché la Bri oggi conta meno di ieri o è merito della diplomazia italiana?
Nel contesto della diplomazia bilaterale, la Bri non è altro che un’espressione della volontà di mantenere aperti canali di comunicazione e collaborazione da entrambe le parti. Il punto chiave qui è che non esiste alcun tipo di rapporto di tutoraggio o “clientelismo”. Che si tratti di un “partenariato strategico” o della Bri, le interazioni tra Italia e Cina hanno una base sufficientemente ampia per continuare a trovare livelli confortevoli di impegno socio-economico. A volte si tende a considerare ogni accordo Bri uguale, ma non è così. Nel caso di alcune economie/Paesi i cui legami con la Cina erano deboli e limitati alla rappresentanza tra governi, la Bri ha permesso di ampliare i contatti tra enti governativi e società. Ma non è il caso dell’Italia. Le imprese e i diplomatici italiani sono sempre stati esplorativi a livello mondiale, anche in Cina. Come lo sono i cinesi.
Di Alessandra Colarizi
[Pubblicato su Il Fatto quotidiano]
Classe ’84, romana doc. Direttrice editoriale di China Files. Nel 2010 si laurea con lode in lingua e cultura cinese presso la facoltà di Studi Orientali (La Sapienza). Appena terminati gli studi tra Roma e Pechino, comincia a muovere i primi passi nel giornalismo presso le redazioni di Agi e Xinhua. Oggi scrive di Cina e Asia per diverse testate, tra le quali Il Fatto Quotidiano, Milano Finanza e il Messaggero. Ha realizzato diversi reportage dall’Asia Centrale, dove ha effettuato ricerche sul progetto Belt and Road Initiative. È autrice di Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro.