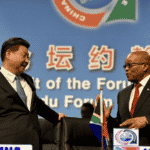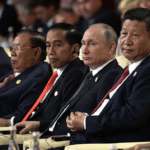Dall’ultimo numero di Africa Rossa, la rubrica su Cina e Africa a cura di Alessandra Colarizi:
- Cina, Russia e Sudafrica sempre più vicine
- Crollano del 54% gli investimenti cinesi nelle infrastrutture africane
- Ombre cinesi sulle elezioni in Nigeria
- Dal “modello Angola” al “modello Lekki”
- Una Bretton Woods “con caratteristiche cinesi”
- Basta con la trappola del debito!
- I torbidi retroscena della ferrovia Mombasa-Nairobi
- Una strategia decentralizzata per l’Africa
- L’Uganda comincerà a esportare petrolio (verso la Cina?)
- La “BRI europea” punta sull’Africa
“Le ragionevoli preoccupazioni della Russia sulla sicurezza dovrebbero essere rispettate e prese sul serio.” Tra gli appelli di pace, dal palco di Monaco il capo della diplomazia cinese , Wang Yi, ha ricordato come Pechino considera l’invasione dell’Ucraina una reazione alle provocazioni della NATO. Non tifa per la guerra, ma condivide le preoccupazioni di Mosca. Il pressing americano aumenta e il contesto geopolitico suggerisce che la minaccia dell’accerchiamento è una sindrome avvertita anche in Cina. La comunione di vedute non potrebbe essere più chiara a sud di Richards Bay, dove dal 22 al 27 febbraio Cina, Russia e Sudafrica hanno condotto esercitazioni navali congiunte. Le operazioni hanno coinciso con il primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina.
Non è la prima volta che i tre paesi schierano le proprie forze navali al largo del Sudafrica – una prima versione delle Exercise Mosi si era tenuta nel 2019. Il tempismo rende tuttavia la manovra particolarmente controversa. Soprattutto considera il provocatorio sfoggio di muscoli di Mosca. Per parte russa a guidare le esercitazioni è stata la fregata Admiral Gorshkov, armata di missili ipersonici Zircon. Molto è stato scritto e detto sul significato dell’insolita triangolazione: il Sudafrica utilizza strumentazione di fattura locale e occidentale, fattore che limita l’interoperabilità con la flotta cinese e russa. Quindi l’operazione potrebbe avere soprattutto un valore simbolico. A guadagnarci è soprattutto la Mosca, che ha potuto sfoggiare – oltre al proprio arsenale – una cerchia di amicizie consolidate. Pochi ma buoni, come si dice.
Per i padroni di casa le esercitazioni servono a potenziare la marina contro la pirateria. Ma anche ad affermare l’autonomia di Pretoria in politica estera: alla fine di gennaio il governo di Cyril Ramaphosa era stato fortemente criticato per aver concesso ormeggio alla ro-ro Lady R, una nave russa sanzionata dal Tesoro americano. Le esercitazioni Mosi II complicano la posizione del Sudafrica, che a marzo 2022 giustificò l’astensione dal voto Onu di condanna contro la Russia citando la storica affiliazione al movimento dei non-allineati. Il fatto è che, mentre l’African National Congress (il partito di governo) ricorda ancora con gratitudine il supporto di Mosca durante la guerra di liberazione dal giogo coloniale, il Sudafrica si considera anche un importante partner NATO. Il “non-allineamento” consiste proprio in questo: avvalersi del diritto di non fare una scelta di campo. Ma è comprensibile l’irritazione delle cancellerie europee. Soprattutto considerato il tentativo obliquo di ravvivare lo spirito anti-imperialista per consolidare la popolarità dell’ANC tra gli elettori. Secondo Paul Stronski del Carniege, “molti vedono anche i doppi standard dell’Occidente: l’intenso sostegno che l’Occidente ha dato all’Ucraina militarmente e ai rifugiati ucraini in Europa, mentre non ha dato un aiuto simile ai conflitti africani o ai rifugiati”.
Per la Cina – che partecipa con il cacciatorpediniere lanciamissili Huainan, la fregata Rizhao e la nave rifornimento Kekexilihu – Mosi è un’occasione per estendere le proprie attività marittime nell’Oceano Indiano, rafforzare la presenza in acque internazionali. Anche nell’ottica della possibile apertura di un’altra base navale lungo le coste africane, oltre a Gibuti. Il Global Times spiega che “Le intense interazioni estere, inclusa la partecipazione a esercitazioni congiunte, mostrano che il PLA sta attivamente aumentando il suo scambio militare e la sua cooperazione con altri paesi nell’era post-COVID”. E poi ovviamente a trarre beneficio è anche la piattaforma dei BRICS. Come scrivevo l’ultima volta, la sigla potrebbe cominciare presto a includere altri paesi africani. E non è escluso che le esercitazioni Mosi siano un primo passo per ampliarne lo spettro di interesse dalla sfera politico-economica a quella militare.
Crollano del 54% gli investimenti cinesi nelle infrastrutture africane
C’è stato un tempo in cui la Cina concedeva prestiti a occhi chiusi. Oggi non più. Secondo uno studio della Fudan University di Shanghai, lo scorso anno la Cina ha destinato all’Africa subsahariana appena 4,5 miliardi di dollari in finanziamenti e investimenti per il settore delle costruzioni, rispetto agli 8,1 miliardi di dollari nel 2021. Un tonfo che – pur essendo generalizzato – si fa sentire soprattutto in un settore un tempo emblema del protagonismo cinese nel continente: nell’ultimo anno i prestiti nelle opere ferroviarie africane sono scesi a quota zero. I numeri trovano conferma nel database della Boston University, secondo il quale nel 2020 i prestiti al continente sono scesi al livello più basso dal 2004.
C’entra il Covid ma non solo. Lo aveva detto Xi Jinping nel 2021: i progetti cinesi in futuro dovranno essere “piccoli e belli”. Il problema è quello ormai arcinoto del debito. Un problema per l’Africa ma anche per la Cina. Non a caso uno dei paesi in cui è più evidente il disimpegno cinese è l’Angola, la nazione del continente in cui a partire dai la Cina ha sperimentato il modello “infrastrutture in cambio di petrolio” (esteso ad altri stati ricchi di risorse minerarie). Buona parte della ricostruzione nazionale post-guerra civile è stata finanziata da Pechino. Oggi però Luanda è il governo africano più indebito verso la Cina (36,6 miliardi di dollari) e il secondo più indebitato al mondo dopo il Pakistan (77,3 miliardi). Fattore che ha spinto il governo di João Lourenço a chiedere meno e Pechino a dare meno. Lo scorso anno a dare niente.
E’ la fine della Belt and Road? Non esattamente. Proprio in Angola sono in corso le prime manovre di assestamento: poche settimane fa il governo angolano ha firmato con l’Exim Bank prestiti agevolati per 249 milioni di dollari per la realizzazione di una rete Internet a banda larga. Il progetto prevede la costruzione di un cavo ottico terrestre di 2.000 km (1.240 miglia) in Angola, nonché una linea sottomarina fino all’enclave di Cabinda e un potenziamento della rete di telecomunicazioni del paese.
Il tutto in risposta all’avanzamento di Africell, risposta americana, a Huawei per il controllo della tecnologia 5G nel Paese. L’industria tecnologica, insieme al comparto energetico, sta sostituendo i trasporti in cima alla lista della spesa cinese (guarda caso durante l’ultima visita della segretaria al Tesoro Janet Yellen gli Stati Uniti hanno reso noto di voler investire in Africa più di 350 milioni di dollari per agevolare l’accesso ad internet e potenziare le competenze digitali ed imprenditoriali nel continente più giovane al mondo).
Ombre cinesi sulle elezioni in Nigeria
Come in altre parti del mondo, anche in Africa, il crescente protagonismo delle aziende delle telecomunicazioni cinesi ha fatto scattare diversi campanelli d’allarme. Il tema è tornato d’attualità soprattutto in Nigeria, dove domenica si sono tenute le elezioni più complicate degli ultimi vent’anni. Cosa c’entra la Cina? Seguendo un copione visto altrove, Atiku Abubakar, candidato del principale partito d’opposizione, ha cercato di mettere in cattiva luce la fazione politica del presidente uscente, Muhammadu Buhari, rimarcandone proprio gli stretti rapporti con Pechino. Negli ultimi due anni ha fatto molto discutere l’espansione di Huawei nel paese, soprattutto dopo che il colosso di Shenzhen ha stretto accordi per formare 1000 dipendenti pubblici in materia di sicurezza informatica, e per costruire un sistema di sorveglianza elettronica lungo il confine. Da tempo circolano voci secondo cui la Nigeria vorrebbe dotarsi di un Great Firewall in stile cinese.
Dal modello Angola al modello Lekki
Più tecnologia e meno “cattedrali nel deserto”, dicevamo. Cambiano i settori di interesse ma anche le modalità di investimento. Ancorare i prestiti alle risorse si è dimostrato rischioso non solo in Angola. Nella Repubblica Democratica del Congo le autorità locali hanno chiesto un’approfondita revisione di un accordo da 6,2 miliardi di dollari firmato nel 2008, in base al quale la Cina si era impegnata a costruire strade e ospedali in cambio di quote di partecipazione nel conglomerato minerario Sicomines. Un’indagine simile ha coinvolto la proprietà di China Molybdenum Co. nel giacimento di rame e cobalto di Tenke Fungurume (TFM). Il governo di Felix Tshisekedi ritiene che gli accordi stretti dal predecessore Joseph Kabila siano iniqui considerato il valore delle risorse cedute ai cinesi di molto superiore rispetto ai progetti realizzati. Proprio l’oscillazione dei prezzi delle materie prime è uno dei fattori ad aver complicato la situazione creditizia dei partner africani. Così Tshisekedi vuole riallineare i piatti della bilancia, guarda caso a circa un anno dalle prossime elezioni che lo vedranno gareggiare per un secondo mandato. A fronte dei 17 miliardi di dollari richiesti, la China Railway Engineering Corporation (CREC) ha accettato di costruire altri 500 milioni di ferrovie entro l’anno. Un compormesso che, per ora, sembra aver messo a tacere le polemiche.
Nel frattempo però si ragiona su come passare verso un modello di cooperazione Cina-Africa meno dipendente dalle risorse naturali. Un possibile caso di studio è il porto di Lekki, in Nigeria, dove China Harbor Engineering Corp (CHEC) – che ha finanziato e costruito le infrastrutture – sta sperimentando in una joint venture con l’operatore portuale francese CMA nella gestione dello scalo. L’idea è che, prendendo parte ai progetti, le aziende costruttrici da una parte siano incentivate ad avviare i lavori con prudenza, dall’altra facciano di tutto per assicurare la qualità dei progetti affinché diventi economicamente sostenibile. Come mette in risalto Hong Zhang, ricercatrice del CARI, in un recente studio, il nuovo paradigma di sviluppo potrebbe svincolare i progetti cinesi dai prestiti sovrani, “facendo in modo che le società di investimento (cinesi) si assumano il debito come parte del finanziamento di progetti.” Sono ancora solo ipotesi: CHEC non ha alcuna esperienza nella fase operativa, e così la maggior parte dei conglomerati cinesi impegnati nel settore delle costruzioni.
Una Bretton Woods “con caratteristiche cinesi”
Di debito africano si è parlato anche venerdì durante la riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20. “Sono diversi i punti di vista intorno al tavolo su come affrontare [la questione] ma credo sia giusto dire che c’è un accordo comune [o] un accordo condiviso sulla necessità di includere la cancellazione del debito come uno degli strumenti che possono fornire supporto al Paesi più vulnerabili”, ha spiegato la ministra delle Finanze indiana, Sitharaman Nirmala. “Quattro paesi specifici trarranno vantaggio [da] una rapida risposta da parte delle istituzioni internazionali”: Ghana, Sri Lanka, Etiopia e Zambia, ha chiarito Sitharaman.
Tradotto dal politichese: niente di fatto.
Il meeting si è tenuto dopo settimane di polemiche: prima Yellen e poi l’ex direttore uscente della World Bank, David Malpass, hanno accusato duramente la Cina di aver ostacolato i negoziati sulla riduzione del debito africano. Pechino si è impuntato su una questione non da poco: ovvero sul fatto che anche Banca mondiale e Fondo monetario internazionale dovrebbero venire coinvolte nelle trattative e nella condivisione delle perdite nel processo di ristrutturazione. Una cosa mai successa prima d’ora.
Citando i dati del ministero delle Finanze dello Zambia, le autorità cinesi hanno affermato che le grandi istituzioni finanziarie multilaterali rappresentano il 24% del debito estero di 
Basta con la trappola del debito!
Sulla questione del debito si sono espressi diversi esperti. Su The China Global South Project Eric Olander ha fatto notare come negli ultimi due decenni il debito dei paesi a basso e medio reddito verso istituti di credito privati è balzato dal 10 al 50%. Questo debito – che ha tassi elevatissimi (in media del 12%) si è dimostrato molto più difficile da ristrutturare perché a differenza dei prestatori bilaterali, come la Cina, i fondi di investimento privati rappresentano migliaia di obbligazionisti e non hanno un rapporto politico con il paese mutuatario. Anche il diritto fiduciario negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove sono quotati molti di questi fondi, rende la ristrutturazione terribilmente complessa. Preoccupati dal caso dello Zambia, a settembre oltre 100 economisti riconosciuti a livello mondiale hanno scritto una lettera aperta per denunciare le società di investimento private occidentali – come BlackRock – accusate di astenersi da qualsiasi concessione per difendere i propri profitti.
Dello stesso tenore l’editoriale di Deborah Brautigam su Foreign Affairs, in cui l’esperta avverte che “per mantenere la Cina a bordo”, gli altri paesi del G-20 devono “sostenere una condivisione più equa degli oneri finanziari tra creditori privati, pubblici e forse multilaterali”. “Gli Stati Uniti devono ripensare la loro strategia miope di fare della Cina un capro espiatorio come attore non cooperativo,” afferma l’analista della John Hopkins. Al tempo stesso, Pechino “deve accettare che le svalutazioni del debito sono inevitabili”. Esattamente come in Ucraina, il problema è che la risoluzione della crisi è ostaggio delle rivalità tra Cina e Stati Uniti. The China Global South Project ha analizzato le contorsioni della propaganda cinese: “When it Comes to the Global South Debt Crisis, the Chinese Message is Clear: Don’t Talk About China, Just Focus on the West”, titola il portale.
- L’Etiopia (il secondo paese africano più indebitato verso la Cina) pare stia facendo progressi nella ristrutturazione del suo debito, stimato intorno ai 13 miliardi di dollari. Una delegazione di alto livello è stata recentemente a Pechino, dove ha concordato con i creditori una rinegoziazione del debito attraverso “mezzi alternativi”, tra cui procedure di “debt swap”, e “incentivi per gli investitori cinesi”.
I torbidi retroscena della ferrovia Mombasa-Nairobi
La Corte Suprema del Kenya ha fatto luce sull’accordo per la costruzione della famigerata ferrovia Mombasa-Nairobi. Dalle testimonianze raccolte è emerso come il progetto sia stato compromessa dalla collusione tra attori cinesi e kenioti fin dall’inizio: a quanto pare le autorità cinesi hanno esercitato pressioni sul Kenya affinché fosse la China Road and Bridge Corporation (CRBC) a vincere la gara, precondizione per il finanziamento del progetto. Sempre alla CRBC sono state affidate le operazioni di valutazione dell’impatto ambientale, in chiaro conflitto di interessi. A quanto pare il debito non è l’unico problema a offuscare la ferrovia.
Anche in Etiopia i progetti cinesi stanno attraversando un periodo difficile. Recentemente la Cina è dovuta intervenire con la fornitura di pezzi di ricambio per un valore di 155 milioni di yuan (23 milioni di dollari) per la rete tranviaria elettrificata di Addis Abeba. Per l’economista Alemayehu Geda “la linea ferroviaria della capitale etiope era un progetto mal pianificato ed eseguito che è andato avanti per motivi puramente politici ed era destinato a fallire”. Secondo The Reporter, la metropolitana leggera ha generato entrate per appena 11,1 milioni di dollari nei suoi primi quattro anni di vita, ma il suo funzionamento è costato ben 154 milioni di dollari. E il debito sale.
L’Uganda comincerà a esportare petrolio
Alla fine di gennaio il governo ugandese ha annunciato il via al primo programma di perforazione nel giacimento di Kingfisher, nel distretto di Kikuube. È il primo passo verso lo sfruttamento commerciale del petrolio in Uganda. Un punto di non ritorno per un progetto più che controverso che Kampala accarezza da 20 anni, quando le sue riserve di greggio -intatte- sono state stimate in 1,4 miliardi di barili. Kingfisher fa parte di un maxi progetto di sfruttamento del petrolio in Uganda da 10 miliardi di dollari lanciato dalla francese Total e della CNOOC cinese. A regime il singolo giacimento dovrebbe produrre 40mila barili di greggio al giorno, circa il 20% di quello che potrà essere inviato per l’export verso la Tanzania. E da lì verso la Cina?
Una strategia decentralizzata per l’Africa
Tempo fa parlavamo di come sempre più spesso i rapporti economici con l’Africa vengono portati avanti dalle autorità provinciali. E’ quello che Charlotte Lenz del Lse Ideas definisce strategia del “gemellaggio” un modello collaborativo tra attori centrali e locali. Secondo questo tipo di cooperazione decentrata, gli agenti centrali formulano le politiche, mentre i governi provinciali si occupano della fase attuativa. Secondo l’esperta, “il carattere distintivo della Cina – il gemellaggio delle province cinesi, vale a dire degli attori sub-statali, con gli stati africani – istituzionalizza gli impegni a lungo termine, aumenta l’efficienza e genera una conoscenza più approfondita delle condizioni locali.”
La BRI europea punta sull’Africa
Alla fine di gennaio l’Ue ha rilasciato i dettagli della “Global Gateway”, il piano per respingere la Belt and Road cinese. Sui complessivi 70 progetti lanciati nel primo anno di attività, 36 sono collocati nell’Africa subsahariana, inclusa l’espansione del porto di Mindelo, a Capo Verde, e del porto di Banjul, in Gambia, la costruzione di un cavo sottomarino in fibra ottica per collegare i paesi del Mediterraneo al Nord Afric, nonché una diga e una centrale idroelettrica in Camerun.
A cura di Alessandra Colarizi
Per chi volesse una panoramica d’insieme, il 2 settembre è uscito in libreria “Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro” (L’Asino d’Oro, 14,00 euro). Partendo dal racconto dei primi contatti nella storia, il testo cerca di restituire un’immagine a tutto tondo dei rapporti sino-africani, superando la dimensione puramente economica. Mentre la narrazione dei mass media ci bombarda quasi ogni giorno con le statistiche del debito africano e degli investimenti cinesi, “Africa rossa” cerca di riportare al centro della narrazione gli scambi politici e socio-culturali tra i rispettivi popoli.

Classe ’84, romana doc. Direttrice editoriale di China Files. Nel 2010 si laurea con lode in lingua e cultura cinese presso la facoltà di Studi Orientali (La Sapienza). Appena terminati gli studi tra Roma e Pechino, comincia a muovere i primi passi nel giornalismo presso le redazioni di Agi e Xinhua. Oggi scrive di Cina e Asia per diverse testate, tra le quali Il Fatto Quotidiano, Milano Finanza e il Messaggero. Ha realizzato diversi reportage dall’Asia Centrale, dove ha effettuato ricerche sul progetto Belt and Road Initiative. È autrice di Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro.