A fine settembre, periodo in cui cade la Giornata internazionale per l’aborto libero e sicuro, India e Thailandia hanno varato misure che liberalizzano l’interruzione di gravidanza, ampliando i servizi a sempre più categorie di donne o allungando il tempo massimo entro cui poter sottoporsi all’aborto. Ma altrove la pratica resta illegale. Questo contenuto è stato realizzato per la newsletter settimanale creata per i nostri sottoscrittori. Scopri qui come riceverla.
Lo scorso 29 settembre la Corte Suprema indiana ha stabilito che tutte le donne, indipendentemente dallo stato civile, potranno abortire fino a 24 settimane di gravidanza. Un periodo di tempo che era prima concesso solo alle donne sposate, mentre alle nubili era imposto il limite della ventesima settimana. “L’interruzione di gravidanza non sarà considerata un crimine”, si legge invece nel comunicato condiviso il 27 settembre dal governo thailandese. Bangkok si avvia a legalizzare l’aborto fino a 20 settimane di gestazione. Un allentamento delle misure, entrate in vigore solo a febbraio dello scorso anno, che permettevano l’interruzione di gravidanza fino alla dodicesima settimana. A febbraio 2020 la Corte Costituzionale si era opposta alle norme del Codice Penale che criminalizzavano l’aborto, che era considerato pratica illegale a eccezione di casi specifici, come lo stupro o serie minacce alla vita della madre.
ABORTO IN THAILANDIA
- Il recente emendamento, che è entrato in vigore il 26 ottobre, prevede che le donne che si trovano tra la dodicesima e la ventesima settimana di gestazione debbano attendere l’approvazione di un medico autorizzato per procedere con la pratica abortiva. È consentito organizzarsi in completa autonomia, invece, per chi rientra nelle dodici settimane di gestazione.
- Nel paese a maggioranza buddista la pratica è ancora afflitta da forte stigma sociale. E proliferano le cliniche abortive illegali: uno scandalo risalente a più di dieci anni fa aveva attirato l’attenzione proprio su questo problema, dopo che nel 2010 erano stati scoperti 2000 feti in attesa di cremazione nell’obitorio del tempio Wat Phai Ngern, a Bangkok. Le indagini avevano portato all’arresto di tre persone, accusate di gestire una clinica illegale, e avevano scatenato un ampio dibattito sull’inadeguatezza della legge in vigore.
LA SITUAZIONE IN INDIA
- Secondo il massimo tribunale indiano, il Medical Termination of Pregnancy Act (il testo di riferimento del 1971), “non rispecchia più il paese di oggi”. Le associazioni di attivisti e alcuni membri del governo di Nuova Delhi parlano della sentenza della Corte Suprema come di “una vittoria per il desiderio collettivo delle donne”.
- Un ulteriore passo avanti rispetto all’emendamento dello scorso anno, quando la Corte indiana aveva ampliato l’accesso ai servizi abortivi sicuri e legali “per motivi terapeutici, eugenetici, umanitari e sociali”. In quell’occasione il limite per l’interruzione di gravidanza era stato esteso dalle 20 alle 24 settimane per le donne divorziate, le minori, le vittime di stupro e altre categorie vulnerabili come le diversamente abili. Lasciando fuori, tuttavia, quelle nubili.
- In India la pratica abortiva viene utilizzata ancora per fini “selettivi”: negli ultimi 50 anni, ha riportato il The Guardian, sono stati abortiti 46 milioni di feti femminili, molto meno graditi dei futuri bambini maschi. Il governo di Narendra Modi sembra essersi limitato a prendere atto dei recenti dati secondo cui per la prima volta la popolazione indiana conta più donne che uomini, quasi a voler dimostrare che il problema non abbia in realtà comportato uno squilibrio di genere.
L’ABORTO IN ASIA
Lo scorso giugno Nikkei Asia ha pubblicato un lungo articolo sull’aborto nel continente asiatico, che menziona anche il rinnovato dibattito emerso nell’area a seguito del rovesciamento della sentenza Roe vs Wade del 1973 da parte della Corte suprema statunitense (sulla reazione del web cinese alla sentenza abbiamo dedicato una puntata di Weiboleaks, la rubrica di Lucrezia Goldin). I dati riportati dal Nikkei, raccolti e condivisi dal Guttmacher Institute, un’organizzazione statunitense attiva nella promozione dei diritti sessuali, segnalano una media di 36 milioni di aborti praticati ogni anno in Asia.
Ma nel continente le politiche in merito, e la percezione pubblica, sembrano seguire variabili diverse rispetto al consueto dibattito tra movimenti pro-choice e pro-life che si riscontra nei paesi occidentali. Risulta difficile parlare di autodeterminazione femminile anche nei paesi in cui l’aborto è legale, in quanto la questione rispecchia norme sociali e problemi demografici.
È il caso del Giappone, il primo paese dell’area a legalizzare l’interruzione di gravidanza nel 1948. All’epoca misura necessaria per limitare il boom della popolazione in un paese devastato dalla guerra, nel 2021 le nascite nel paese hanno toccato il minimo storico per il sesto anno consecutivo. Una tendenza, sostengono gli analisti, che alimenta la stigmatizzazione dell’aborto e spinge il governo a promuovere aggiustamenti restrittivi in merito.
Negli ultimi anni, infatti, Tokyo ha aumentato le pene per i medici che praticano aborti illegali. E si è rifiutata di rispondere alle pressioni degli attivisti per rimuovere la clausola della legge in vigore (la Mathernal Health Act) che rende obbligatorio il consenso del partner di sesso maschile. L’approvazione del coniuge sarà richiesta anche per ottenere la pillola abortiva, che sarà disponibile nel paese non prima della fine del 2022.
Quello della Repubblica Popolare Cinese è ad oggi uno dei tassi di abortività più alti al mondo: delle circa 40 milioni di gravidanze annuali che si sono registrate nel paese dal 2015 al 2019, oltre 23 milioni erano indesiderate. Di queste, il 78% sono terminante con l’aborto (a fronte di una media globale del 61%).
La situazione sul fronte delle politiche demografiche è forse la più nota in Asia: nel 1979 il Partito aveva lanciato la controversa politica del figlio unico per far fronte alla crescita esponenziale della popolazione. La sua abolizione, nel 2016, non ha segnato un cambio di rotta: dopo una breve crescita di nascite nello stesso anno, il tasso di natalità è tornato a diminuire e lo scorso anno ha toccato l’1,3%, tra i più bassi al mondo. Come Tokyo, anche Pechino teme le conseguenze della tendenza demografica in discesa in termini di consumi interni, produttività del lavoro e sistema di previdenza sociale.
Le stime parlano chiaro: entro il 2030 un quarto della popolazione cinese avrà superato i 60 anni. Un trend che Xi Jinping ha tentato di arginare, nel 2021, aprendo alla possibilità per le coppie cinesi di avere fino a un massimo di tre figli. E annunciando ad agosto dello scorso anno precise misure per promuovere la “crescita familiare”, che mirano tra le altre cose a disincentivare le donne (soprattutto se minorenni) ad abortire se non necessario per scopi medici.
La Corea del Sud ha depenalizzato l’aborto nel 2021, dopo che già nel 2019 la Corte Costituzionale aveva stabilito che il divieto della pratica abortiva si schierasse contro la libertà di autodeterminazione delle donne incinte. Diversamente da Cina e Giappone, negli anni Cinquanta il paese aveva reso la procedura illegale per far crescere la popolazione all’indomani delle grandi perdite sofferte durante la guerra di Corea. La pena prevista per chi si sottoponeva all’interruzione di gravidanza era di un anno.
L’aborto è legale anche a Taiwan (proprio a Taiwan abbiamo dedicato l’ebook di settembre). Promulgata nel 1985, la Genetic Health Act pone tuttavia una serie di condizioni: non solo precise ragioni mediche, di salute mentale e lo stupro, ma anche il consenso del marito, a meno che quest’ultimo non sia scomparso o incapace di intendere, o dei genitori, nel caso di minori di 20 anni nubili. La pena detentiva per gli aborti praticati illegalmente può arrivare a sei mesi.
Come in India, l’aborto selettivo è una pratica diffusa anche in Vietnam, tanto da venire considerata una delle cause di uno squilibrio di genere che nel 2026, secondo le statistiche ufficiali, comporterà un’eccedenza di 1,38 milioni di maschi. Il paese ha il secondo tasso abortivo più alto al mondo: ogni anno circa il 40% delle gravidanze del paese terminano con una interruzione.A garantire l’accesso all’aborto è l’articolo 44 della Public Health Protection Law, che non impone alcuna restrizione ufficiale fino alla ventiduesima settimana. Una liberalizzazione che si scontra con un ampio stigma sociale, soprattutto da parte della forte comunità buddista, secondo cui feti ed embrioni sono “anime viventi”.
Nelle Filippine e in Indonesia, le religioni musulmana e buddista, stigmatizzano o ostacolano l’interruzione di gravidanza. In Indonesia chi si sottopone a pratiche abortive rischia fino a 10 anni di carcere: un assetto normativo che in molti casi ha sollevato dure polemiche, come accaduto dopo la condanna detentiva di sei mesi ai danni di una ragazza quindicenne per aver abortito dopo essere stata stuprata dal fratello. La legge vigente permette l’interruzione di gravidanza nel caso di gravi problemi di salute che comprometterebbero la gestazione del feto, o se le gravidanze sono frutto di rapporti sessuali non consensuali. Ma spesso le vittime non possiedono i mezzi culturali ed economici per comprendere il proprio stato di gravidanza prima delle sei settimane entro le quali è legale abortire.
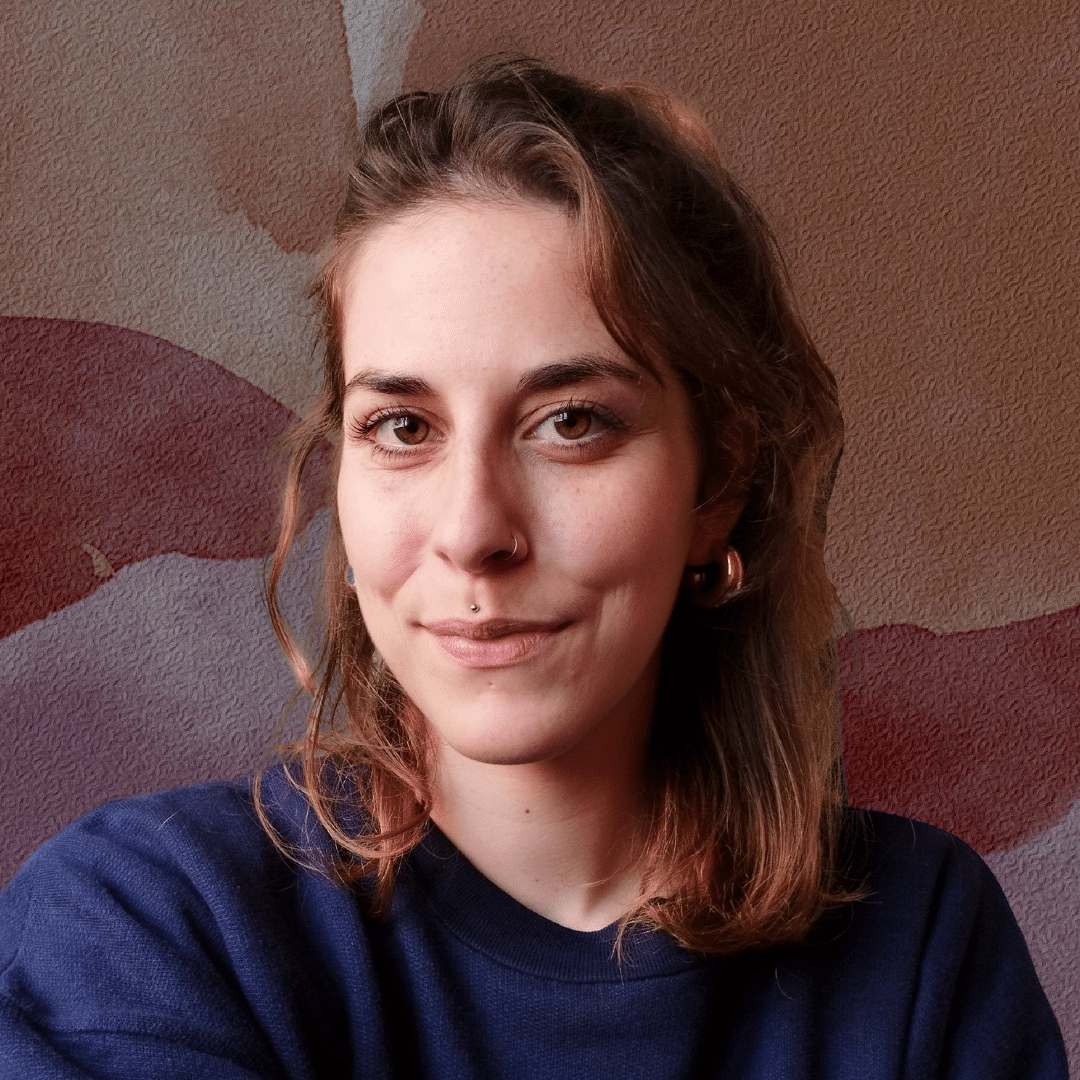
Marchigiana, si è laureata con lode a “l’Orientale” di Napoli con una tesi di storia contemporanea sul caso Jasic. Ha collaborato con Il Manifesto, Valigia Blu e altre testate occupandosi di gig economy, mobilitazione dal basso e attivismo politico. Per China Files cura la rubrica “Gig-ology”, che racconta della precarizzazione del lavoro nel contesto asiatico.


