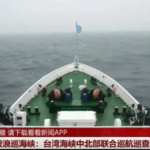Anche senza sviluppi concreti, la visita in Tibet di Paola Pampaloni, vicedirettrice generale per l’Asia e il Pacifico dell’European External Action Service, è degna di nota per diverse ragioni. Innanzitutto, per il tempismo: avvenuta a dieci anni dalla precedente e mentre i dissapori sulla guerra in Ucraina e i veicoli elettrici cinesi hanno compromesso le relazioni tra Pechino e Bruxelles.
Nel pieno delle tensioni geopolitiche e commerciali, Cina e Unione Europea (UE) hanno trovato inaspettatamente un tema su cui confrontarsi senza minacce di sanzioni e tariffe: i diritti umani.
Il 16 giugno si è tenuta a Chongqing la 39a sessione del dialogo congiunto sui diritti umani Cina-UE, la piattaforma creata nel 1995 per riannodare i rapporti bilaterali dopo il massacro di piazza Tienanmen. Solo pochi giorni prima, il meeting è stato preceduto da una rara visita nella regione autonoma del Tibet (TAR), la prima di un alto funzionario europeo dal settembre 2013, quando a recarsi sul “Tetto del mondo” era stato il rappresentante speciale dell’UE per i diritti umani, Stavros Lambrinidis. La missione – stavolta guidata da Paola Pampaloni, vicedirettore generale per l’Asia e il Pacifico dell’European External Action Service – è durata dal 13 al 15 giugno e ha interessato la città di Lhasa nonché la prefettura di Nyingchi.
“L’evento è stato organizzato dalle autorità cinesi competenti a livello centrale e locale”, si apprende dal sito dell’UE, secondo il quale “il programma ha previsto visite a collegi, comuni, siti culturali e religiosi, famiglie tibetane trasferite [dalle campagne] e anche a una prigione. La visita ha rispecchiato la maggior parte delle richieste dell’UE, anche se non è stato possibile scambiare informazioni dirette con i singoli detenuti. Il programma breve e denso ha offerto l’opportunità di acquisire una certa comprensione della realtà sul campo e delle sfide nella regione autonoma del Tibet. A seguito della visita, l’UE ha avanzato diverse raccomandazioni per garantire la piena educazione bilingue, la preservazione del patrimonio culturale, dell’identità e delle libertà fondamentali del popolo tibetano. L’UE incoraggia un numero maggiore di visite da parte della comunità internazionale e delle organizzazioni della società civile.” Secondo il comunicato, la delegazione europea ha inoltre chiesto che la scelta dei leader religiosi – compreso il successore del Dalai Lama – avvenga “senza alcuna interferenza da parte del governo e nel rispetto delle norme religiose”. E’ inoltre stato intimato il rilascio immediato degli intellettuali Go Sherab Gyatso e Tashi Dorje, quest’ultimo in carcere dal 2008. Al netto delle aperture auspicate, il linguaggio utilizzato dalle autorità comunitarie evidenzia toni decisamente più diplomatici dello scorso anno, quando Bruxelles definì lo stato dei diritti umani in Tibet “terribile”.
Anche senza sviluppi concreti, la visita di Pampaloni è degna di nota per diverse ragioni. Innanzitutto, per il tempismo: avvenuta a dieci anni dalla precedente e mentre i dissapori sulla guerra in Ucraina e i veicoli elettrici cinesi hanno compromesso le relazioni tra Pechino e Bruxelles. Che la Cina voglia sfruttare “l’apertura” sui diritti umani per ricucire i rapporti bilaterali? Il dubbio c’è, tanto più considerato il rifiuto riservato a Washington. Secondo il Dipartimento di Stato americano, solo nel 2023 funzionari statunitensi hanno presentato tre richieste per viaggi ufficiali nella TAR, nessuna delle quali è stata approvata (a luglio Joe Biden ha firmato una nuova legge che promuove colloqui tra Pechino e il Dalai Lama, congelati dal 2011, ma che allo stesso tempo sembra contestare i diritti storici della Cina sulla regione autonoma). Intuibile la diffidenza dei gruppi per la difesa dei diritti umani. L’International Campaign for Tibet ha paragonato la visita europea ai “Potemkin village tours” di epoca sovietica. Ovvero una messa in scena, così come tale venne definita la trasferta nello Xinjiang dell’ex Alto Commissario Michelle Bachelet, avvenuta nel maggio 2022 prima del rilascio di un’attesa indagine sul sistema della rieducazione degli uiguri.
Occupata manu militari da Mao nel 1950 al grido “Liberiamo il Tibet dagli imperialisti e dagli schiavisti”, la regione autonoma è oggi una delle zone più controllate e meno accessibili della Repubblica popolare senza autorizzazione speciale. Freedom House le ha recentemente assegnato un punteggio di libertà pari a 0 su un massimo di 100. Mentre i rapporti tra autorità comuniste e popolazione tibetana sono sempre stati conflittuali, la situazione è gradualmente peggiorata con l’inizio della presidenza Xi Jinping. Oggi le limitazioni alle libertà sul “Tetto del mondo” vengono giustificate nel nome della cosiddetta “sinizzazione etnica”: la politica voluta dal governo centrale per uniformare i gruppi minoritari alla maggioranza han, “cinese doc”, ed eliminare le presunte influenze straniere.
Secondo una recente ricerca di Human Rights Watch, dal 2016 “più di 3 degli oltre 4,5 milioni di tibetani che vivono nelle zone rurali sono stati costretti a costruire case e ad abbandonare il loro tradizionale stile di vita nomade basato sull’allevamento di yak e sull’agricoltura”. “Questi trasferimenti di intere comunità rurali erodono o causano gravi danni alla cultura e agli stili di vita tibetani, anche perché la maggior parte dei programmi di ricollocazione in Tibet spostano gli ex agricoltori e pastori in aree dove non possono esercitare i loro mezzi di sostentamento e non hanno altra scelta che cercare lavoro come lavoratori salariati nelle industrie non agricole”, si legge nel rapporto.
Pechino definisce il fenomeno una forma di migrazione “volontaria”: per le nuove generazioni è normale aspirare a una vita più agiata in città. Il governo, dal canto suo, però non nasconde di esercitare un ruolo attivo in quella che chiama “rivitalizzazione rurale”. Il piano per emancipare le campagne e le zone più arretrate del paese, anche attraverso l’insegnamento della lingua cinese standard. Spesso senza possibilità di scelta. Su queste colonne avevamo raccontato la diffusione dei collegi statali, strutture realizzate per ospitare i bambini mandati a studiare lontano dalle famiglie. Anche se, secondo quanto ci spiega Timothy Grose, docente del Rose-Hulman Institute of Technology ed esperto di minoranze cinesi, è riscontrabile “qualche esagerazione in alcuni resoconti”. “A differenza di alcuni collegi per uiguri (soprattutto a livello nazionale), sembra esserci ancora spazio per la lingua e la cultura tibetana, almeno in alcuni di questi istituti”, precisa Grose.
La situazione in Tibet è stata recentemente discussa anche all’interno del Consiglio per i diritti umani dell’Onu. Il Consiglio dispone di un meccanismo in base al quale tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite sono sottoposti a valutazioni periodiche sui diritti umani. A inizio luglio, durante l’ultima revisione che ha riguardato la Cina, l’International Campaign for Tibet ha affermato che 21 paesi hanno sollevato la questione tibetana. Nonostante l’intensa attività di lobbying di Pechino, si tratta del numero più alto dalla prima revisione della Cina, nel 2009.
Di Alessandra Colarizi
[Pubblicato su Gariwo]
Classe ’84, romana doc. Direttrice editoriale di China Files. Nel 2010 si laurea con lode in lingua e cultura cinese presso la facoltà di Studi Orientali (La Sapienza). Appena terminati gli studi tra Roma e Pechino, comincia a muovere i primi passi nel giornalismo presso le redazioni di Agi e Xinhua. Oggi scrive di Cina e Asia per diverse testate, tra le quali Il Fatto Quotidiano, Milano Finanza e il Messaggero. Ha realizzato diversi reportage dall’Asia Centrale, dove ha effettuato ricerche sul progetto Belt and Road Initiative. È autrice di Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro.