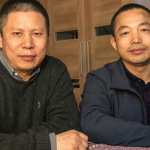Il caso dell’avvocato Lu Siwei conferma come il Sud-est asiatico si sta dimostrando un’area del mondo particolarmente collaborativa quando si tratta di rimpatriare le voci scomode in Cina. In collaborazione con Gariwo Onlus.
Potrebbe trovarsi già in una cella cinese Lu Siwei, l’avvocato arrestato in Laos lo scorso 28 luglio mentre cercava di raggiungere la moglie negli Stati Uniti. Secondo Radio Free Asia, l’11 settembre l’ambasciata cinese a Vientiane avrebbe notificato al Ministero della Sicurezza pubblica che il 3 settembre Lu “è stato autorizzato alla detenzione penale” dalla polizia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina. L’accusa è di “attraversamento illegale di confine”. Nel documento, circolato nei giorni scorsi sui social media, si “esige che il sospettato sia trasferito in Cina e consegnato alla giustizia il prima possibile”.
La notizia del rimpatrio dell’avvocato – avvenuto, pare, insieme a quello di decine di connazionali sospettati di traffico di essere umani e altri reati – è ancora in attesa di conferma. Secondo quanto spiega a Gariwo Laura Harth, campaign director dell’ONG Safeguard Defenders, “diverse fonti lo danno ancora dentro al paese. Per ora la linea è che se il Laos disputa la notizia che sia stato deportato dovrebbe al più presto garantire l’accesso a Lu per i suoi avvocati e l’ONU”.
Specializzato in diritto finanziario e penale, negli ultimi anni Lu si è occupato molto anche di diritti umani. Nel 2019 ha difeso uno degli attivisti accusati di aver diffuso bottiglie di vino commemorative del massacro di piazza Tienanmen. Ma i veri guai per l’avvocato sono cominciati con la detenzione dei 12 attivisti di Hong Kong fermati dalla guardia costiera cinese mentre cercavano di scappare a Taiwan in seguito alle proteste pro-democrazia del 2019. Una visibilità che gli è costata non solo l’interdizione alla professione legale con revoca della licenza. Da allora l’attivista è rimasto sotto stretta sorveglianza delle autorità senza possibilità di lasciare la Cina con mezzi leciti. A luglio ci ha quindi provato clandestinamente, attraversando il Laos nella speranza di riuscire a prendere un treno per la Thailandia. Ma, scoperto in possesso di documenti di viaggio falsi, è stato messo in stato di fermo.
Come noto, la stretta sugli avvocati cinesi è cominciata nel 2015, quando nel giro di pochi mesi oltre 200 professionisti del settore sono finiti in manette in varie parti della Cina. Negli ultimi tempi, tuttavia, la lunga mano di Pechino ha cominciato a raggiungere anche chi era riuscito a fuggire all’estero: l’istituzione di associazioni assistenziali parastatali e presunte stazioni di polizia in 53 paesi ha permesso al governo cinese di continuare l’inseguimento anche oltreconfine. Spesso esercitando pressione sulle comunità diasporiche. Altrettanto spesso sfruttando i legami con i regimi amici. Il Sud-est asiatico si sta dimostrando un’area del mondo particolarmente collaborativa quando si tratta di rimpatriare le voci scomode in Cina. Appena un mese prima che Lu venisse arrestato, il dissidente Yang Zewei era stato prelevato dalla sua casa di Vientiane e riportato in patria, dove adesso deve rispondere all’accusa di sovversione.
Secondo Safeguard Defenders, sono almeno sei i casi di attivisti cinesi sequestrati in Laos. Ventidue quelli registrati in tutto il Sud-est asiatico: rapimenti segreti o con il supporto dei governi locali. Ma “il numero è certamente molto più alto”, spiega Peter Dahlin fondatore dell’ONG con base a Madrid, specificando che le cifre conteggiate non includono i fuggiaschi “persuasi a tornare”. Tra le storie più eclatanti degli ultimi anni va ricordato il rimpatrio forzato di venti uiguri dalla Cambogia nel 2009, la scomparsa dell’attivista cinese Dong Guangping in Vietnam nell’agosto 2022, e soprattutto quella di Gui Minhai: il libraio di Hong Kong, sparito in Thailandia nel 2015, è riapparso tre mesi dopo sull’emittente cinese CCTV in una videoconfessione in cui ha riconosciuto la propria responsabilità in un incidente stradale avvenuto dieci anni prima.
A favore di Pechino gioca la forte presenza economica nella regione: nei primi otto mesi del 2023, il commercio tra la Cina e i paesi ASEAN ha raggiunto quota 566,89 miliardi di dollari, mentre nel 2021 la Repubblica popolare è diventata la principale fonte di investimenti diretti esteri nell’area, a pari merito con il Giappone. Difficile dire di no quando in ballo ci sono affari tanto sostanziosi. D’altronde, accogliere le richieste cinesi non richiede grande sforzo da quelle parti, considerata la deriva autoritaria che caratterizza i paesi ASEAN; anche quelli dove ufficialmente il potere viene esercitato dal popolo, tramite rappresentanti liberamente eletti. Basti pensare che, stando all’indice stilato da Freedom House, in tutto il Sud-est asiatico solo Timor Est è da considerarsi una democrazia a pieno titolo. Nel caso del Laos, influiscono entrambi i fattori: la forte dipendenza dai prestiti cinesi, pari a oltre tre quinti del debito esterno di Vientiane. E la presenza di un sistema politico monopartitico di orientamento marxista-leninista.
Come mette in risalto su Nikkei Asia Review Hoang Thi Ha, senior fellow presso il ISEAS-Yusof Ishak Institute, è possibile riscontrare un nesso tra il consolidamento degli interessi cinesi all’estero e la necessità di garantire sicurezza in quei paesi dove lo Stato è più debole. Da qui il programma di cooperazione con la polizia locale, avviato da Pechino anche in Italia nel 2016. Nel Sud-est asiatico l’ingerenza delle forze dell’ordine cinesi è diventata più marcata da quando negli ultimi anni la regione si è affermata come uno degli hub principali per truffe, tratta di esseri umani e altre attività criminali. Da inizio settembre oltre 1400 cinesi sono stati rimpatriati dal Myanmar, dove erano stati arrestati per aver condotto frodi telefoniche. Secondo il Global Times, il Ministero della Sicurezza pubblica cinese e il relativo dipartimento nello Yunnan, provincia confinante con il Myanmar, “hanno schierato la polizia locale per intensificare gli sforzi attraverso la cooperazione tra le forze dell’ordine di frontiera per portare avanti le operazioni di repressione, liberare le basi fisiche per le frodi e arrestare le persone coinvolte nel tentativo di salvaguardare risolutamente le proprietà e i diritti legali del popolo cinese”.
Di Alessandra Colarizi
[Pubblicato su Gariwo]
Classe ’84, romana doc. Direttrice editoriale di China Files. Nel 2010 si laurea con lode in lingua e cultura cinese presso la facoltà di Studi Orientali (La Sapienza). Appena terminati gli studi tra Roma e Pechino, comincia a muovere i primi passi nel giornalismo presso le redazioni di Agi e Xinhua. Oggi scrive di Cina e Asia per diverse testate, tra le quali Il Fatto Quotidiano, Milano Finanza e il Messaggero. Ha realizzato diversi reportage dall’Asia Centrale, dove ha effettuato ricerche sul progetto Belt and Road Initiative. È autrice di Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro.