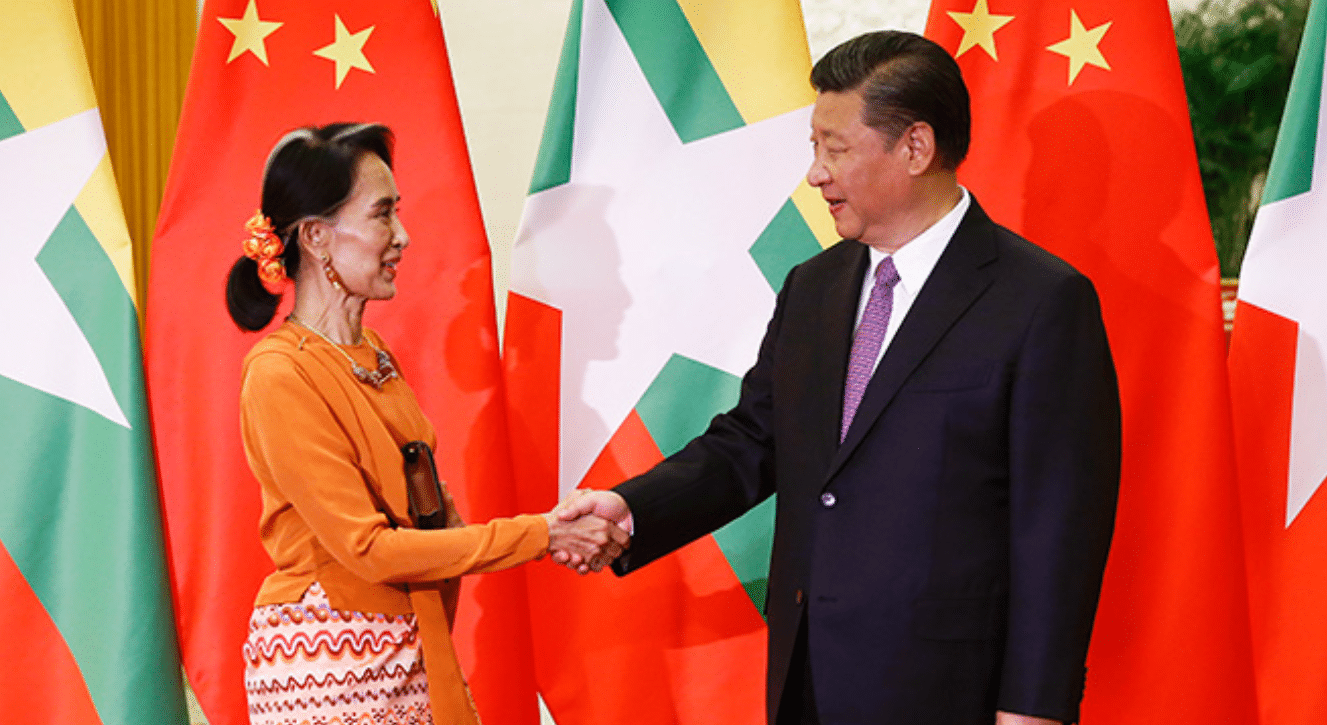Appena tre settimane prima del colpo di Stato, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi era in Myanmar per cementare le “relazioni fraterne” tra i due paesi. “La Cina apprezza che l’esercito consideri la rivitalizzazione nazionale come sua missione”, rassicurò il capo della diplomazia cinese incontrando il generale Min Aung Hlaing. Pechino sapeva delle trame dei militari? La domanda non ha risposta. Certo è che la crisi birmana coglie più alla sprovvista l’Occidente di quanto non sconvolga il regime della porta accanto. Se non altro per i legami di lunga data coltivati con la giunta militare fino alla “transizione democratica” del 2011 e alla rimozione delle sanzioni internazionali imposte dopo il primo arresto di Aung San Suu Kyi.
“Ci auguriamo che tutte le parti possano gestire adeguatamente le loro differenze in base alla costituzione e salvaguardare la stabilità politica e sociale “, recita il comunicato ufficiale del governo cinese che ha definito il colpo di mano “un rimpasto” politico. Come sempre in questi casi, Pechino si trincera dietro al principio della non ingerenza negli affari altrui con la speranza di ottenere lo stesso trattamento quando a finire sotto la lente sono le violazioni dei diritti umani oltre la Muraglia. Ma dietro al linguaggio felpato della diplomazia cinese si nascondono i pro e i contro della crisi birmana.
La parola chiave è “stabilità”, precondizione necessaria per fare affari e prevenire che il caos raggiunga il confine condiviso, già scosso da tumulti etnici. L’esercito sarà in grado di mantenerla? Negli ultimi anni, il Myanmar è diventato un importante terminale della Belt and Road. Qui Pechino ha avviato progetti infrastrutturali ed energetici che gli consentono di raggiungere l’Oceano Indiano aggirando l’impervio stretto di Malacca. Nel 2020, i capitali cinesi nel paese hanno raggiunto quota 133,5 milioni di dollari, oltre il 38% del totale degli investimenti stranieri. Ma volgendo lo sguardo indietro si scopre che la fine della giunta militare ha coinciso con un calo verticale dei progetti e dei prestiti cinesi. Un trend (anomalo per il Sudest asiatico) che il Nikkei Asia Review attribuisce da una parte alla necessità di contenere il debito, dall’altra a una crescente diversificazione dei partner di Naypyidaw. Nel caso di nuove sanzioni internazionali, la Cina potrebbe vedere penalizzate alcune sue aziende quotate negli States, ma tornerebbe a rappresentare una scelta obbligata per i militari.
Di riflesso, la fine dell’esperimento democratico birmano preannuncia implicazioni geostrategiche di vasta portata, considerata la svolta autoritaria che negli utlimi anni ha interesato vari paesi del quadrante. C’è chi paventa una nuova suddivisione della regione in sfere di influenza come ai tempi della Guerra Fredda. In sede Asean, un Myanmar autocratico potrebbe affiancare Laos, Thailandia e Cambogia nella cerchia delle nazioni inclini a sostenere Pechino nei contenziosi marittimi con i vicini rivieraschi. Uno scenario che mette a rischio i piani dell’amministrazione Biden, decisa a contenere l’avanzata cinese nell’Indo-Pacifico ripristinando la rete di alleanze regionali fatta a pezzi da Trump.
[Pubblicato su il manifesto]
Classe ’84, romana doc. Direttrice editoriale di China Files. Nel 2010 si laurea con lode in lingua e cultura cinese presso la facoltà di Studi Orientali (La Sapienza). Appena terminati gli studi tra Roma e Pechino, comincia a muovere i primi passi nel giornalismo presso le redazioni di Agi e Xinhua. Oggi scrive di Cina e Asia per diverse testate, tra le quali Il Fatto Quotidiano, Milano Finanza e il Messaggero. Ha realizzato diversi reportage dall’Asia Centrale, dove ha effettuato ricerche sul progetto Belt and Road Initiative. È autrice di Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro.